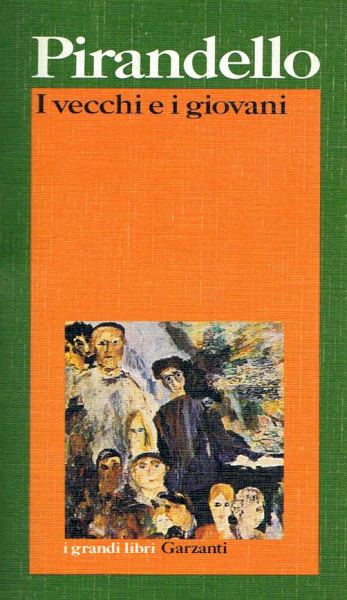««« Capitolo 7 Parte II – Capitolo 1 »»»
««« Introduzione ai romanzi di Luigi Pirandello
Acquista «I Vecchi e i giovani» su Amazon
VIII.
Nella casa di donna Caterina Auriti Laurentano, il giorno delle elezioni, erano raccolti intorno a Roberto i pochi amici rimasti fedeli, riveduti in quei giorni, mutati come lui dal tempo e dalle vicende della vita. Per un momento, negli occhi di ciascuno, abbracciando l’amico, era guizzato lo sguardo della gioventù, di quei giorni lontani, ignari di ciò che la sorte riserbava; e, subito dopo, fra un lieve tentennìo del capo, quegli occhi s’eran velati di commozione mentre le labbra si schiudevano a uno squallido sorriso. «Chi ci avrebbe detto», esprimevano quello sguardo velato e quel sorriso, «chi ci avrebbe detto allora, che un giorno ci saremmo ritrovati così? che tante cose avremmo perdute, che erano tutta la nostra vita allora, e che ci sarebbe parso impossibile perdere? Eppure le abbiamo perdute; e la vita ci è rimasta così: questa!» Più penosa ancora era la vista di qualcuno che non s’era accorto, o fingeva di non accorgersi tuttavia delle sue perdite, e lo mostrava nella cura della propria persona rinvecchignita, da cui spiravano, compassionevolmente affievolite, le arie e le maniere d’un’altra età. Ciascuno s’era adattato alla meglio alla propria sorte, s’era fatto un covo, uno stato. Sebastiano Ceràulo, avvocato di scarsi studii, fervido improvvisatore di poesie patriottiche negli anni della Rivoluzione, giovine allora animoso, impetuoso, con una selva di capelli scarmigliati, era entrato per favore come segretario negli ufficii della Provincia, e si raffilava ora sul cranio con miserevole studio i quattro lunghi peli incerottati che gli erano rimasti; s’era ingrassato enormemente; aveva preso moglie; ne aveva avuto cinque figliole, ora tutte smaniose di trovar marito. Un altro, Marco Sala, condannato a morte dal governo borbonico, e pur non di meno tante volte dall’esilio venuto in Sicilia travestito da frate per diffondervi segretamente i proclami del Mazzini, s’éra dato prima al commercio dello zolfo; aveva avuto fortuna per alcuni anni; poi un tracollo; e per parecchio tempo aveva mantenuto col giuoco la famiglia; alla fine aveva avuto il posto di magazziniere dei tabacchi. Rosario Trigóna, che nella giornata del 15 maggio del 1860, a Girgenti, mentre Garibaldi combatteva a Calatafimi, era uscito solo, pazzescamente, con altri quattro compagni, la bandiera tricolore in una mano e uno sciabolone nell’altra, incontro ai tre mila uomini del presidio borbonico, e che, inseguito, tempestato di fucilate, era scampato per miracolo e aveva raggiunto a piedi Garibaldi vittorioso, correndo di giorno e di notte e sfuggendo all’esercito regio che s’internava nella Sicilia in cerca del Filibustiere, il quale era intanto a Gibilrossa sopra Palermo; Rosario Trigóna, disfatto adesso dalla nefrite, gonfio, calvo, sdentato e quasi cieco, sovraccarico anch’esso di famiglia, vivucchiava miseramente col magro stipendio di vice-segretario alla Camera di Commercio. E Mattia Gangi, che aveva buttato la tonaca alle ortiche per prender parte alla Rivoluzione, ora, asmatico, rabbioso, con la barba, i capelli e le foltissime sopracciglia ritinti d’un color rosso di carota, insegnava nel ginnasio inferiore alauda est laeta, e «lieta un corno!», soggiungeva ai ragazzi con tanto d’occhi sbarrati: «ma che lieta! non ci credete, canta perché ha fame, canta per chiamare! lieta un corno!». Contrastava con questi Filippo Noto, alto, magro, appassito, ma ancora biondiccio e azzimato. Prima del ’60 s’era battuto in duello con un ufficialetto borbonico per motivo di donne ed era stato perseguitato; quell’avventura amorosa era divenuta per lui un precedente patriottico; ma s’impacciava poco di politica: studiando molto, era riuscito a tenersi a galla, a rinnovarsi coi tempi, pur rimanendo malva, conservatore; passava per uno degli avvocati più dotti del foro siciliano, ed era spesso chiamato a difendere le più importanti cause civili anche a Palermo, a Messina, a Catania.
Questi cinque amici e il canonico Agro si sforzavano di tener desta la conversazione, parlando di cose aliene, di avvenimenti lontani, ricordando aneddoti che promovevano qualche riso stentato; tanto per impedire che col silenzio il peso della sconfitta, quantunque prevista, gravasse maggiormente su gli animi oppressi. Ma veramente, a poco a poco, dopo la prima scossa nel riveder l’amico e ora per la commozione crescente nel rievocare gli antichi ricordi della gioventù, cominciava a scomporsi in loro la coscienza presente, e con una specie di turbamento segreto che li inteneriva avvertivano in sé la sopravvivenza di loro stessi quali erano stati tanti e tanti anni addietro, con quegli stessi pensieri e sentimenti che già da un lungo oblìo credevano oscurati, cancellati, spenti. Si dimostrava vivo in quel momento in ciascuno di loro un altro essere insospettato, quello che ognun d’essi era stato trent’anni fa, tal quale; ma così vivo, così presente che, nel guardarsi, provavano una strana impressione, triste e ridicola insieme, dei loro aspetti cangiati, che quasi quasi a loro medesimi non sembravano veri. Di tratto in tratto, però, entrava nel salotto Antonio Del Re, che li vedeva vecchi com’erano, e che, stando un pezzo a udire i loro discorsi, provava una tristezza indefinita, la tristezza che si prova nel veder nei vecchi, che per un tratto si dimenticano d’esser tali, ancora verdi certe passioni che hanno radici in un terreno oltrepassato, che noi ignoriamo.
– Ci eravamo trattenuti a San Gerlando, – raccontava Marco Sala, – a giocare fin quasi a mezzanotte in casa di Giacinto Lumìa, buon’anima.
– Povero Giacinto! – sospirò il Trigóna, scrollando il capo.
– C’era con noi Vincenzo Guarnotta di Siculiana, – seguitò il Sala.
– Ah, Vincenzo! – disse Roberto Auriti. – Che ne è?
– Morto, – rispose il Sala.
– Anche lui?
– Eh, sarà nove o dieci anni!
Con quel suo sorriso perenne, più degli occhi che della bocca… occhi chiari, di mare, col nudo faccione di terracotta… «Ah! sti cazzi! chi mi pigli pi fissa?» – scomparso anche lui.
– Era venuto a Girgenti per affari, e alloggiava, come usava allora che non c’erano alberghi, nel convento di Sant’Anna. Adesso, neanche il convento c’è più! Nottata da lupi: vento, lampi, tuoni e acqua, acqua che il tetto pareva ne dovesse subissare. Tanto che Giacinto Lumìa alla fine propose a tutti di rimanere a dormire in casa sua. Ci saremmo accomodati alla meglio. Gli altri, scapoli, e il Guarnotta, forestiere, accettarono l’invito; io, non ostanti le preghiere insistenti, volli andarmene per non tenere in pensiero mia madre, sant’anima, e mia moglie. Prima d’andarmene, il Guarnotta, sapendo che per arrivare a casa dovevo passare per lo stretto di Sant’Anna, mi pregò di bussare alla porta del convento per avvertire il frate portinajo ch’egli quella notte avrebbe dormito fuori. Glielo promisi e andai. Vi assicuro che, appena su la via, mi pentii di non avere accettato l’ospitalità del Lumìa. Che vento! portava via! frustava la pioggia, densa come piombo; e freddo e bujo, un bujo che s’affettava, dopo gli sprazzi paurosi dei lampi. Tuttavia, passando per lo stretto di Sant’Anna, mi ricordai di quel che m’aveva detto il Guarnotta e mi fermai a picchiare alla porta del convento. Picchia e ripicchia: niente! non mi sentiva nessuno! per miracolo non buttai la porta a terra. Stavo per andarmene, su le furie, quando sentii schiudere una finestra ferrata in alto; e un vocione: «Chi è là?». «Sala», dico, «Marco Sala!» «Va bene!», risponde allora il vocione di lassù; e subito dopo sento sbattere di nuovo e sprangare la finestra. Restai come un allocco. Non mi avevano dato il tempo di parlare, e andava bene? Mi scrollai dalla rabbia, pensando che per far piacere al Guarnotta che se ne stava al coperto, io, col rischio di prendere un malanno, per giunta ero passato forse per mattoo per ubriaco. Chi poteva girare a quell’ora, con quel tempo? Fatti pochi passi, sento per lo Stretto un rintocco di campana, – don – lento, che mi fece sobbalzare; e il vento propagò il suono, lúgubremente, nella notte; poi, di nuovo,don, don, altri rintocchi; saranno stati quindici; non ci badai più. Arrivato a casa, mi strappai gli abiti, che mi s’erano incollati addosso; mi asciugai ben bene; mi cacciai a letto, e buona notte. La mattina dopo, m’alzo presto, com’è mia abitudine, vado per aprire la porta, e indovinate chi mi trovo davanti? I portantini col cataletto. Appena mi vedono, levano le braccia, dànno un balzo indietro; rimangono basiti: «Don Marco! Ma come? Voscenza non è morto?». «Figliacci di cane!», grido io levando il bastone. E quelli: «Sissignore… A Sant’Anna, stanotte, sono venuti ad avvertire che Voscenza era morto!». Quella campana, capite? aveva sonato a morto per me. Ed ero andatoio stesso ad annunziare la mia morte.
Benché la storiella non fosse allegra, le ultime parole del Sala furono accolte dalle risa degli amici.
– Ridete? – diss’egli. – Eppure chi sa se non sono morto davvero, io, allora, cari miei! Ma sì! Posso dire che quella fu l’ultima nottata allegra della mia gioventù! Forse, ripensandoci, l’impressione di quei rintocchi mi s’è fissata, mal augurosa; ma mi sembra che proprio da allora la vita mi si sia chiusa tra un diluvio di guaj, sia divenuta per me come era lo stretto di Sant’Anna in quella notte da lupi, e che quei don don della campana a morto mi abbiano seguito per tutto il cammino…
Rientrò, in quel punto, Antonio Del Re con un nuovo telegramma. Ne erano già arrivati parecchi dalle varie sezioni elettorali del collegio. Il canonico Agro lo aprì, lo lesse con gli occhi soltanto e lo buttò in un canto, su la sedia presso al canapè. Né Roberto né gli altri si curarono di sapere da che sezione venisse, che esito recasse. Il gesto e il silenzio dell’Agro avevano reso inutile ogni domanda. La sconfitta del momento, che toccava all’Auriti, rendeva più evidente quella, ben più grave e irrimediabile, che a ciascuno era toccata dal tempo e dalla vita. E questa sconfitta pareva avesse la propria immagine scolpita in donna Caterina Auriti Laurentano, taciturna e scura. Di tratto in tratto gli amici e Roberto le volgevano uno sguardo fuggevole, come a uno spettro del tempo, di cui essi erano i superstiti vani. Altre voci erano nel nuovo tempo, che non trovavano eco negli animi loro; altri pensieri che non entravano nelle loro menti; altre energie, altri ideali, innanzi a cui i loro animi si chiudevano ostili. E la prova era patente e cruda in quel mucchio di telegrammi su la sedia. Era sorta improvvisamente, negli ultimi giorni, ma certo preparata in segreto da lunga mano, la candidatura d’un tale Zappalà di Grotte, perito minerario: candidatura esplicitamente dichiarata come di protesta e d’affermazione dei lavoratori delle zolfare e delle campagne della provincia, già raccolti in fasci. Roberto Auriti era passato in terza linea. In quasi tutte le sezioni quello Zappalà aveva raccolto più voti di lui, mettendolo così fuori di combattimento, d’un tratto spiccio e sprezzante, come si butterebbe da canto con un piede uno straccio inutile, ingombro più che inciampo. A un certo punto, quando arrivò il telegramma da Grotte ch’era uno dei maggiori centri zolfiferi della provincia con l’esito della votazione quasi unanime per lo Zappalà, parve che costui dovesse finanche contender seriamente la vittoria al Capolino ed entrare in ballottaggio, non ostante il suffragio entusiastico che il campione clericale aveva raccolto a Girgenti, in compenso della grave ferita riportata nel duello. Il Trigóna, per coprire con pietoso inganno la verità, voleva attribuire principalmente la sconfitta all’esito di quel duello inconsulto, alle maniere troppo violente del Verònica, forestiere, e al contegno arrogante d’uno dei suoi padrini, quel signor tale, spadaccino, che aveva urtato e indignato veramente la cittadinanza girgentana, non ostante che il Selmi, già partito per il suo collegio, avesse fatto di tutto per attenuare l’indignazione. Il canonico Agro approvò col capo, in silenzio. Non sapeva perdonare al Verònica di avergli mandato a monte, con quella indegna piazzata, il piano strategico meditato e disegnato da lui con astuzia così sottile. E quell’altro cavaliere Giovan Battista Mattina! Mandato a Grotte a sostenervi la candidatura dell’Auriti, aveva fatto la parte di Giuda, mettendosi d’accordo all’ultimo momento coi popolari.
– Ma chi è costui? – domandò col solito piglio feroce Mattia Gangi. – Chi rappresenta? come vive? che fa? da qual chiavica è scappato fuori? Lindo, attillato, con quell’aria di principe regnante…
Il canonico Agro scosse leggermente la testa con un sogghignetto su le labbra, poi disse:
– Aquiloni, cari amici, aquiloni! Lui, il Verònica e quanti altri mai! Aquiloni… Li vedete in alto, ai sette cieli, rimanete a bocca aperta a mirarli; e chi sa intanto qual è la mano che dà loro il filo! Può esser quella di qualche mala femmina; o il filo può venire dalla Questura, o da qualche bisca notturna… Nessuno può saperlo! L’aquilone intanto è là, piglia il vento, lo segue e par che lo domini. Di tratto in tratto, uno svarione, una vertigine, l’accenno d’un crollo a capofitto. Ma la mano ignota, sotto, subito lo rialza con lievi scossettine sapienti o con larghe stratte energiche e lo rimette a vento e torna a dar filo e filo e filo. Gli aquiloni, cari miei… Quanti ce n’è! E hanno tutti la coda, et in cauda venenum…
Sei teste si scossero per approvare silenziosamente e con profonda amarezza l’immaginoso paragone del canonico Agro, che ne rimase egli stesso un pezzetto come abbagliato, e trasse un respiro di sollievo, quasi con esso si fosse scrollato dall’anima il peso della sconfitta.
Roberto Auriti soffriva maggiormente per quell’ostinato, cupo silenzio della madre. Ella aveva parlato molto prima, contro il suo solito, per dissuaderlo dall’impresa; e gravi erano state allora le sue parole; più grave, adesso, era il suo silenzio. Voleva che soltanto i fatti parlassero ora, crudamente, a conferma di quanto aveva detto. Se ne irritò, e disse:
– Del resto, amici miei, aquiloni o serpi… lasciamoli andare! A parlarne, parrebbe che io, venendo, mi fossi fatta qualche illusione. Nessuna, lo sapete. Mi ha mandato qua Uno, a cui non potevo dir di no: mi sarebbe parso di disertare.
– Povero Cristo! – esclamò Mattia Gangi. – Per farti mettere in croce sei venuto!
– In croce no, veramente, – sorrise Roberto. – Perché la mia offerta, col valore che poteva avere nella presente lotta, venisse respinta dai miei concittadini; e questa risposta, data sul mio nome al Governo, facesse pensare che ormai basta, qua si vuol altro!
– Zappalà, Zappalà si vuole! – sghignò allora Mattia Gangi. – Quanto mi piacerebbe che fosse eletto Zappalà!
– Mamma, – soggiunse piano Roberto, toccandole un braccio, con un sorriso d’amara rassegnazione, – asini vecchi…
La madre sporse il labbro e aggrottò le ciglia mentre gli altri gridavano, approvando l’augurio di Mattia Gangi, che fosse eletto Zappalà. Un Zappalà solo? No! Cinquecentootto Zappalà, uno per ogni collegio della penisola! Che sedute allora alla Camera! Subito, abolizione di tutte le scuole! abolizione di tutte le tasse! abolizione dell’esercito e della polizia! della polizia e della pulizia! spianare i confini, e tutti fratelli! già, già, decapitare le montagne, ridurle tutte a colline d’uguale altezza! E Mattia Gangi, sorto in piedi, si mise a declamare:
Al ronzio di quella lira
Ci uniremo, gira gira,
Tutti in un gomitolo.
Varietà d’usi e di clima
Le son fisime di prima;
È mutata l’aria.
I deserti, i monti, i mari,
Son confini da lunari,
Sogni di geografi…
… E tu pur chétati, o Musa,
Che mi secchi con la scusa
Dell’amor di patria.
Son figliuol dell’universo,
E mi sembra tempo perso
Scriver per l’Italia.
S’eran levati tutti in piedi, tranne Pompeo Agro, e applaudivano calorosamente.
– Signori miei, signori miei, – disse allora Filippo Noto, tirandosi con le dita adunche i polsini di sotto le maniche, – siamo giusti, signori miei; non pigliamocela con loro, perché il torto è tutto nostro! di noi cristianelli! Quando noi sentiamo dire: «Vogliamo che a ciascuno si dia secondo le sue opere! Vogliamo che la personalità umana possa elevarsi sopra la vita materiale! Vogliamo che ciascuno trovi pane e lavoro!» – noi borghesucci ignoranti, noi cristianelli pietosi, siamo i primi ad applaudire…
– Sfido! – gridò il Ceràulo. – Nei voti per la felicità universale, sfido! tutti gli animi onesti si trovano d’accordo.
– E i socialisti, ahm! aprono la bocca, e voi ci cascate dentro, – rimbeccò pronto Filippo Noto. – Fanno intravedere un ideale d’umanità e di giustizia che a nessuno può dispiacere, di cui tutti dovrebbero esser contenti; e così fanno proseliti alla loro causa tra quanti non sanno distinguere le ragioni astratte da quelle pratiche della vita sociale, caro Ceràulo! Ingenui che non si domandano neppure se i nuovi metodi non siano tali da render mille volte maggiori le ingiustizie e la tristezza della nostra valle di lacrime; dico bene, Monsignore?
Pompeo Agro chinò più volte il capo in segno di approvazione.
– Il pericolo vero, signori miei, è qua, – seguitò con più calore il Noto: – nella persuasione in cui siamo venuti noi cristianelli, che il movimento del così detto quarto stato sia inevitabile, irresistibile…
– È, è, è, purtroppo! – lo interruppe di nuovo il Ceràulo.
– Ma nient’affatto! nientissimo affatto! Fandonie! Fandonie! – gridò Filippo Noto. – Alla teoria dei socialisti manca l’appoggio della scienza, caro mio, della scienza, della logica, della morale e anche della civiltà, e non può reggersi, e cadrà per forza come un sogno pazzo, come uno sproloquio da ubriachi! Vorrei dimostrartelo, vorrei dimostrarlo a tutti, e prima a gli uomini di governo che ci fanno assistere allo spettacolo miserando dello Stato che si piega, dello Stato che si smarrisce e s’impaccia di cose di cui non dovrebbe impacciarsi!
Si calmò alquanto, protese le mani e riprese con altro tono di voce:
– Lasciatemi dire, in poche parole. Tutto il procedimento è sbagliato, dall’a alla z. Guardate! Il provvedere ai vecchi, alle donne, ai fanciulli abbandonati, agli infermi, può esser cosa, realmente, d’interesse pubblico.
– Interesse d’umanità, – disse il Trigóna.
– Benissimo! D’accordo! – approvò il Noto. – Ma dal soccorrere la miseria presente per mezzo d’asili, di dormitorii, di cucine economiche, è stato facile, inavvertito il passo, signori miei, a salvaguardare il proletariato…
– Il così detto proletariato, – masticò tra i denti il Gangi.
– …dalla miseria anche possibile, – seguitò il Noto, – mercé le assicurazioni obbligatorie contro gl’infortunii del lavoro e contro la futura inabilità dell’operajo per età o per malattia. Ora non vi sembra facile, cari miei, dati questi primi passi, il darne altri che ci conducano sempre più verso quello Stato-Provvidenza tanto biasimato dai più illustri scrittori positivi? Perché, quando sia entrato nella coscienza pubblica il concetto che la comunità deve occuparsi di coloro che per inabilità fisica non possono lavorare, è facile saltare il fosso che ci separa dalla regione vera del socialismo, estendendo il principio anche agli uomini validi e disoccupati. E valga il vero! Se questi, non ostante la buona volontà, non trovano lavoro, o se le loro fatiche non sono sufficientemente retribuite, sono forse meno da compiangere di coloro che, per un difetto fisico, non possono lavorare? L’effetto è il medesimo, signori miei: la fame non meritata! E con la proclamazione del diritto al lavoro, si può vedere da tutti dove si andrà a finire; si è già veduto, del resto, in Francia, nel 1848…
Un’improvvisa esclamazione di sdegno del canonico Agro interruppe a questo punto il discorso di Filippo Noto, che cominciava ad assumere proporzioni e tono di vera concione.
Era arrivata da Comitini, paese nativo dell’Agro, una lettera che denunziava un altro tradimento. Il figlio di Rosario Trigóna s’era venduto colà al partito Capolino, spargendo la voce che Roberto Auriti si ritirava dalla lotta e pregava gli amici di votare per il candidato clericale contro il socialista Zappalà. L’Agrò non si potè frenare: senz’alcuna pietà per il povero padre mezzo cieco lì presente, ebbe parole di fuoco per quel tristo che gli faceva patire un così grave smacco là, nella sua stessa cittadella. Roberto Auriti tentò più volte di interromperlo, s’affrettò poi a consolare l’amico, il quale dapprima s’era levato in piedi inorridito, lì per lì per lanciarsi su quella lettera e su l’Agrò, poi s’era lasciato cader di peso su la seggiola, rompendo in singhiozzi, col volto tra le mani.
– Ma sarà una calunnia, Rosario… una calunnia, vedrai! Tuo figlio avrà agito in buona fede, credendo di interpretare il mio pensiero… Difatti, tra i due, tra il Capolino e quello Zappalà, via! meglio che i voti siano andati al Capolino… Ha stimato insostenibile da parte mia la lotta… e…
– No… no… – muggiva tra i singhiozzi Rosario Trigóna, inconsolabile. – Infame! Infame!
Per fortuna, sopravvenne Mauro Mortara, che da Valsanìa s’era recato a Colimbètra per accordarsi col principe circa alla sua andata a Roma. Non sapeva nulla delle elezioni. Accolto con festa da Marco Sala, dal Ceràulo, dal Gangi,quali non lo vedevano da tanto tempo, scostò tutti con le braccia e quasi s’inginocchiò ai piedi di donna Caterina, prendendole una mano e baciandogliela più e più volte; abbracciò poi Roberto e’ si chinò a baciarlo al suo solito in petto, sul cuore.
– A Roma! – disse. – Sapete? Vengo a Roma!
Ma il suo giubilo non trovò eco: tutti erano ancora sconcertati e commossi dal pianto del Trigóna.
– Oh, don Rosario! – esclamò Mauro. – E che avete? Perché piangete?
Guardò tutti in giro e appuntò gli occhi sul canonico Agro che appariva il piùscuro e il più turbato.
– Niente, – disse subito Roberto. – Una notizia, senza dubbio, infondata. Signori miei, per carità! Soffro… soffro della vostra pena… molto più che per me. Volete farmi contento? Non parliamo più di nulla. Quel che è stato è stato. Basta! Voi sapete quanto mi siete cari e per qual ragione. Io non vi ringrazio di quel che avete fatto per me in questa occasione, perché so che, se sono cangiati i tempi, non è cangiato il nostro cuore, e voi dunque non potevate non fare per me quel che avete fatto. Il torto è nostro, veramente, cari miei! E lo sappiamo tutti, da un pezzo, chi per un verso, chi per un altro. Dunque… dunque basta: perché lagnarci adesso? È stata un’altra prova, di cui io, per conto mio, non sentivo alcun bisogno… Basta!
Non ne poteva proprio più Roberto Auriti. La vista di quegli amici e il silenzio della madre, il pianto del Trigóna, la stizza acerba dell’Agro, la frigida saccenteria del Noto gli eran divenuti insopportabili. Gli premeva di scrivere a Roma, di dar subito notizia della lotta perduta alla sua donna, a colei che da tanto tempo gli aveva addormentato aspirazioni e sdegni, e nella quale, affogato ormai nell’incuria di tutto ciò che non si riferisse direttamente e minutamente alla sua persona, neghittoso e dimentico, saziava soltanto la fame bruta del senso. Di fronte alla nobiltà della madre, alla purezza della sorella, si sentiva quasi istintivamente costretto a nascondere anche a se stesso la sua schiavitù d’affetto per quella donna che conosceva tutte le sue miserie; e le scriveva di notte. Falsando i proprii sentimenti, per stare in pace con lei e averla docile e pronta alle sue voglie, non aveva osato confessarle prima di partire la vera ragione per cui s’esponeva a quella lotta: le aveva dato a intendere ch’era per migliorare la sua condizione, ponendosi da deputato più in vista. E nelle prime lettere le aveva lasciato sperare non improbabile la vittoria; poi man mano l’aveva messa in dubbio; le aveva scritto in fine che gli premeva ormai soltanto di ritornar presto a lei. Andava lui stesso a impostare quelle lettere, mentre per tutte le altre si serviva del nipote. Eppure sapeva che questi, il giorno appresso, sarebbe partito con lui per intraprendere a Roma gli studii universitarii e avrebbe abitato in casa sua e veduto, dunque, e saputo tutto. Ma voleva, finché era lì, serbare il segreto. Quel giovanotto ispido e angoloso non era fatto certamente per attirar la confidenza d’alcuno. E Roberto soffriva al pensiero di condurlo con sé, di fargli conoscere e di far quindi conoscere per mezzo di lui alla madre e alla sorella la vita ch’egli viveva a Roma. Ma come esimersi?
Donna Caterina, intanto, domandava a Mauro notizie del fratello Cosmo, «di quel matto», e di donna Sara Alàimo.
– Non me ne parlate, per carità! – esclamò Mauro. – Vado a Roma, vi dico, e non so altro, non voglio saper altro in questo momento!
– Caro Mauro mio, – gli rispose allora donna Caterina, sorridendo amaramente, – se è così, chiudi gli occhi, tùrati bene gli orecchi e ritornatene subito in campagna: segui il consiglio mio!
Quando dalla Badia Grande gli amici scesero alla via Atenea, si trovarono presi in mezzo a una fiumana di popolo che esaltava la proclamazione d’Ignazio Capolino.
La carrozza del canonico Agro si dovette fermare. Il vecchio servo-cocchiere dalle zampe sbieche faceva schioccar la frusta: – Ohi, favorì! Ohi, favorì! – Poteva mai figurarsi che si dovesse mancar di rispetto al suo padrone, o che questi dovesse aver paura. E, tra il clamore e la confusione, non udiva la voce del Canonico che gli gridava: – Indietro, Cola! indietro! Per la via del Purgatorio! –. Un fischio, e due, e tre… Figli di cane! Ma Capolino era ancora a letto, convalescente nella villa del principe di Laurentano a Colimbètra, e la dimostrazione di giubilo, per darsi uno sfogo diretto, fu proprio tentata di cangiarsi lì per lì in dimostrazione di protesta contro il canonico Agro. Per fortuna, i caporioni riuscirono a stornar la bufera che stava per rovesciarsi sulla carrozza mal capitata, non per riguardo a Pompeo Agro, che non ne meritava alcuno, ma all’abito che indossava indegnamente. Qualche fischio sì, passando, non sarebbe stato sprecato; poi via, via, alla Passeggiata, sotto la villa di Flaminio Salvo.
– Viva Ignazio Capolinòòò!
– Vivààà!
– Viva il nostro deputatòòò!
– Vivààà!
Nel bujo della sera, sotto il pallore dei lampioni, per l’angusta via passò tumultuando quel torrente di popolo, che si lasciava trascinare senza il minimo entusiasmo, come un armento belante, dalla volontà di due o tre interessati. La villa di Flaminio Salvo era illuminata tutta, splendidamente, perché si vedesse come segno di trionfo dalla lontana Colimbètra. Vi erano raccolti i maggiorenti del partito che si affacciarono tutti al gran balcone dalla balaustrata di marmo, appena i clamori della dimostrazione si fecero sentire giù per il viale.
– Viva Flaminio Salvòòò!
– Vivààà!
– Viva Ignazio Capolinòòò!
– Vivààà!
Salì alla villa una commissione di dimostranti, che fu accolta dal Salvo con quel solito sorriso freddo, a cui lo sguardo lento degli occhi sotto le grosse pàlpebre dava un’espressione di lieve ironia. E veramente quei quindici o sedici cittadini accaldati, usciti or ora dalla moltitudine anonima, che giù nel bujo del viale aveva tanta imponenza, assumendo lì ciascuno il proprio nome, il proprio aspetto, timidi, impacciati, smarriti, ossequiosi, facevano una ben misera figura, tra gli splendori del magnifico salone. Flaminio Salvo si dichiarò grato alla cittadinanza di quella spontanea affermazione del sentimento popolare; diede notizie della salute dell’on. Capolino e, in presenza della commissione stessa, pregò l’ingegnere Aurelio Costa di recarsi sul momento alla villa del principe, a Colimbètra, per darvi l’annunzio della proclamazione e di quella manifestazione di giubilo di tutto il popolo di Girgenti. Uno dei quindici, allora, s’affacciò al balcone e, tra i lumi sorretti da due camerieri, arringò con impeto la folla.
Nessuno badò allo scompiglio delle povere nottole del viale che abbarbagliate piombavan dall’alto a strisciare sulle teste dei dimostranti, quindi al clamore, al battio delle mani, si risollevavano disperatamente, lanciando acutissimi stridi, come per chiedere ajuto e vendetta alle stelle che sfavillavano ilari in cielo. L’oratore improvvisato diceva che l’elezione di Capolino era un avvenimento dei più memorabili della storia italiana contemporanea; ma nessuno certamente avrà potuto levar dal capo a quelle nottole, che invece tutta la città, quella sera, si fosse raccolta soltanto per dare a loro una immeritatissima guerra. Arringava ancora quell’oratore, quando Aurelio Costa su un sauro del Salvo, sellato in fretta in furia, partì di galoppo per Colimbètra.
Giù, confuso tra la folla, era il Pigna, arrivato in coda alla dimostrazione, espurgato smaltito evacuato da essa con molta violenza di conati lungo tutto il percorso. Prepotenza! Sopraffazione! Andava per i fatti suoi, stava a traversar la via Atenea, quando la folla gli era venuta addosso; non aveva fatto in tempo a ritrarsi, e allora quelli che stavano alla fronte lo avevano strappato indietro per passare, e così la fiumana se l’era ingojato: sguizzare, con quelle cianche e quel groppone, non gli era stato possibile; furibondo, urlando, s’era messo a tirare spinte da tutte le parti e pugni e calci e gomitate, per farsi un po’ di largo e uscirne; ma quelli per il gusto di portarselo via con sé come in ostaggio gli s’eran pigiati con furia addosso, gridando: – Ecco Pigna! c’è Pigna! viva Pigna! abbasso Propaganda! no, viva! giù, giù con noi! – e qualche lattone e qualche scapaccione era pur volato; più che mai inferocito, come un cinghiale in mezzo a una muta di cani, aveva avventato anche morsi ai più vicini; più d’una volta, puntando i piedi e le spalle per svincolare un braccio e credendo che la folla dietro lo avrebbe parato, trovando invece un po’ di largo fatto da qualcuno che voleva scansarlo, era stato per cadere; ma subito altri lo avevano scaraventato con un nuovo urtone alle spalle di chi stava davanti, e lì, rinserrato, compresso, boccheggiante come un pesce, altri lattoni e scapaccioni e dileggi; e tira e spingi, se l’erano sballottato così, malmenandolo in tutti i modi, fino a che, pesto, disfatto, non s’era lasciato andare alla corrente, ma con le proprie gambe no, no: là, così, trascinato… – Selvaggi! Mascalzoni! Coscienze vendute! Che spettacolo! Oh Girgenti, disonore della Sicilia e dell’umanità! ludibrio, vituperio! Tutti in sagrestia domani, sì, sì, ad attaccar con le ostie della chiesa le mezze carte da cinque lire… Sì, viva Capolino e viva Salvo! viva Bacco e viva Mammone! – Così esclamando, e guardando con aria di dispetto minaccioso la folla sotto la villa del Salvo, ora s’accomodava una spalla, ora soffiava o sbruffava, ora sorsava col naso, e puh, feccia della umanità! puh, vili ignoranti!
– Domani, Propaga’, sta’ zitto! – gli gridavano alcuni. – Domani c’inscriveremo tutti al Fascio! Ora, qua: Viva Capolinòòò! (Non ci credere, sai? è per minchionare.) Viva! Vivààà!
Questa la conclusione d’una giornata campale, questo il rinfranco di tutte le corse che s’era fatte fin dalla mattina da un seggio elettorale all’altro, per assegnar le parti ai compagni, per dare istruzioni, e qua regolare, e là persuadere, e incitare, e pregare, secondo i casi, che il suffragio di tutti i lavoratori fosse per un lavoratore, loro compagno, perdio! Angelo Zappalà, che li avrebbe difesi, che avrebbe perorato la loro causa in Parlamento!
Sì, dato che quella candidatura popolare doveva valer soltanto quale protesta, egli in fondo avrebbe potuto dichiararsi soddisfatto dell’esito: sì, ma della votazione dei paeselli vicini! il cuore gli faceva sangue invece per la vergogna di Girgenti capoluogo, della sua città natale! Ludibrio, vituperio…
Quando, alla fine, il Pigna, senza più voce, cascante a pezzi dalla stanchezza, si ridusse a casa, al Piano di Gamez, per mandar giù un boccone di cena avvelenato dalla bile, salendo i primi gradini della scaletta di legno che dalla stanza terrena conduceva a quella di sopra, vi trovò al bujo in fitto colloquio Celsina e Antonio Del Re.
– Ohè, voi qua?
– Va’ sù; passa, papà! – gli disse Celsina, come a un cane. – Sto a salutarlo. Parte domani.
– Ah, buona sera, allora, – disse il Pigna. – Cioè, buon viaggio… Partite subito, dunque? V’invidio, caro mio. Oh, vedrete certo a Roma… come viene a essere di voi don Landino Laurentano? già, zio, l’abbiamo detto: riveritelo tanto per me, ditegli che Girgenti ha bisogno di lui; sta disonorando l’isola, Girgenti…
– Abbiamo inteso, papà, – lo interruppe Celsina infastidita. – Lasciaci parlare adesso! Vattene!
– Paese di carogne! – brontolò il Pigna, tirando sù a stento le cianche per la scala. – Farabutti… ohi ohi… ignoranti…
E svoltò. Subito i due giovani si riabbracciarono. Antonio non si reggeva più; ebro, perduto, non poteva più staccarsi da lei; le cercò la bocca, com’arso di sete, per un altro bacio che le penetrasse nel fondo più fondo dell’anima; un altro bacio smanioso, cocente, infinito, col quale darle tutto se stesso e prendersela tutta, nello spasimo del più violento desiderio.
– Basta, – gemette ella, esausta, abbandonandogli il capo sul petto.
Ma egli la stringeva ancora, più ardente; più tremante; voleva ancora la bocca.
– No, basta, Nino, – disse allora Celsina, riavendosi. – Basta… basta…
Gli prese le mani, gliele strinse; se le posò sul seno ansante, senza lasciargliele; riprese:
– Così!… Dunque, senti… tu vedrai, è vero? cercherai… Devi far di tutto…
– Sì…
– M’ascolti?
– Sì…
– Non m’ascolti! Basta, ora, Nino! T’ho detto, basta. Non m’ascolti…
– Sì… cercherò…
– Che cercherai? Lasciami, per carità!
– Non so… farò di tutto… figùrati! Dammi ancora un bacio…
– No! Dove cercherai?
– Ma per tutto, per tutto…
– Sì, un posticino qualunque… infimo anche… per cominciare, capisci?… Tu sai che posso… m’adatterò a fare ogni cosa! Debbo, debbo essere a Roma al più presto, m’ascolti?
– Sì, amore… amore… amore mio! – alitò egli; poi, stringendole le braccia e smaniando: – Come faccio? oh Celsina mia… come faccio?
– Zitto! – gli intimò Celsina. – Non voglio che ti sentano sù.
– Allora vado… non posso…
– Sì, va’, va’… è tardi! Mi chiamano. Scrivimi subito, sai?
– Sì…
– Addio, addio.
Ma egli non sapeva lasciarle ancora la mano; le accostò il volto al volto, le domandò:
– Che mi dài?
– Che vuoi?
– Te, tutta! Vieni con me, vieni con me!
– Potessi! Subito!
– Oh amore… Che mi dài? Qualcosa tua…
– Non ho nulla, Nino mio…
– Eppure ho qualcosa di te, sai? che tu m’hai data.
– Io?
– Non m’hai dato niente tu? Neppure il cuore, un poco?
– Ah, quello…
– E un’altra cosa… Non ti ricordi?
– No…
– La bambola…
– Ah, – sorrise Celsina, – quella coi baffi?
– Non ridere, non ridere. Glieli ho cancellati, sai? Me la porto con me.
– Ragazzo…
– Sai? stanotte è stata con me, abbracciata con me, a letto. E sempre…
– Ma va’! Non sono io, quella, sai!
– Lo so; ma è tua, è stata tua… Non l’hai baciata tu?
– Tanto, da bambina…
– E dunque…
– Va’, va’, Nino. Mi richiamano. Addio. Ricordati, sai? Scrivimi! Addio.
Un altro lungo, lungo bacio sulla porta, e Antonio andò via. Si fermò nel Piano di Gamez deserto; e si guardò intorno, smarrito; guardò sù nel vano immoto dell’aria ed ebbe un senso di stupore, come se, sveglio, fosse entrato in un sogno. Come sfavillavano le stelle! Sentì schiudere la vetrata del balconcino. Celsina s’affacciò.
– Addio. Ricordati.
– Sì. Addio!
Era già lontana; lontana la voce, lontana la figura; e quella casetta, sulla cui facciata chiara in mezzo al Piano umido e nero si rifletteva la luna, e quel Piano stesso, il chioccolìo della fontanella, e quelle anguste viuzze storte, nere, tutto il paese silenzioso nella notte, alto sul colle, sotto le stelle, ogni cosa gli parve come lontana ormai; gli parve come se egli da lontano, con tristezza infinita, con infinita angoscia contemplasse la propria vita che rimaneva lì, strappata da lui.
Quando Aurelio Costa arrivò a Colimbètra, don Ippolito Laurentano sapeva già della proclamazione di Capolino; e ne parlava nel salone con don Salesio Marnilo e con Ninì De Vincentis. Il primo, accorso subito da Girgenti appena conosciuto l’esito del duello; il secondo, dopo lo scontro a cui aveva assistito da testimonio, rimasto a Colimbètra accanto al letto del ferito.
Zio Salesio ascoltava il principe con un’aria di degnazione contegnosa, come se Capolino lo avesse fatto elegger lui. Ma sì, via! non gli aveva dato in moglie la figliastra? Da cinque giorni si sentiva proprio rinato, là tra gli splendori di Colimbètra, nei quali s’invaniva e si ricreava, come se fossero suoi. Camminava su gli spessi tappeti più che mai in punta di piedi; faceva il bocchino a tutte le cose belle e preziose che vedeva; a tavola per poco non sveniva dal piacere davanti a quelle finissime stoviglie luccicanti, o quando Liborio in marsina e guanti bianchi gli presentava i cibi prelibati. E sul tramonto, non ostante che i piedi gli facessero male, scendeva su lo spiazzo e andava fino al cancello per il gusto di farsi salutare militarmente dall’uomo di guardia in calzoni rossi e cappotto turchino. L’uomo di guardia prendeva lo stesso gusto a salutare; e tutti e due, dopo il saluto, si guardavano e si sorridevano.
Ninì De Vincentis pareva non si fosse rimesso ancora del tutto dallo spavento che s’era preso nel veder Capolino piegarsi sulle gambe, ferito in petto dalla pistola del Verònica, al secondo colpo. Era stata, veramente, una terribile sorpresa per tutti, quella ferita. Le pistole, per tacita intesa fra i padrini, erano state caricate in modo da non produrre alcun effetto, volendosi che il vero duello avvenisse alla sciabola. E meno male che la palla, arrivata senza troppa violenza, aveva appena appena intaccato una costola ed era deviata dal cuore! Ma non solo quello spavento teneva ancora il povero Ninì tanto abbattuto e sbalordito; Nicoletta Capolino gli aveva lasciato intendere chiaramente che Dianella Salvo non era né sarebbe mai stata per lui, quand’anche il padre non avesse opposto un così reciso rifiuto alla domanda. Dopo la prima notte vegliata accanto al letto del marito, non ostante l’assicurazione dei medici che ogni pericolo per fortuna fosse scongiurato, Nicoletta si era persuasa che non era più il caso di rappresentar la parte della moglie disperata, come aveva fatto a Valsanìa all’annunzio della ferita toccata «a Gnazio suo». E s’era messa ad alternar le cure amorose e diligenti al suo povero «paladino» ferito con lo studio sapiente di rimaner lì a Colimbètra, nella memoria di don Ippolito Laurentano, ospite graditissima. Ah, se al posto di quella foca di Adelaide Salvo fosse stata lei, là, tra poco, regina di quel piccolo regno! Era certa che tutte le parti buone, di cui si sentiva pur dotata e che la sorte aveva voluto opprimere e soffocare in lei, si sarebbero ridestate liberamente e avrebbero preso alla fine in lei il sopravvento; certo che avrebbe saputo render felici gli ultimi anni di quell’altero e bellissimo vecchio, ancora così vegeto e fresco! Indovinava in lui l’amaro disinganno provato alla vista della futura sposa; ma intuiva che nessun’arte di seduzione sarebbe valsa su quell’uomo, il quale della fedeltà alla parola data s’era fatta quasi una religione. Neppur l’ombra della civetteria, dunque, in lei, ma una gara di cortesie e di compitezze con lui, in quei giorni, senza la minima affettazione. E che prediche a quattro occhi allo zio Salesio, il quale non voleva capire che non c’era più nessuna ragione, proprio, perché si trattenesse ancora a Colimbètra. Sapeva star bene a posto, sì – troppo bene, anzi – zio Salesio; ma… ma… ma… E del suo sogno inattuabile, della nostalgia della bontà, dell’incubo che le cagionava la vista del patrigno così compito e ridicolo, della nausea che in quel momento le dava la sua lunga odiosa finzione d’affetto per quel marito, per quel degno compagno della parte peggiore di sé, Nicoletta si vendicava tormentando Ninì De Vincentis, segnatamente la sera, su quel terrazzo aggettato su le colonne del vestibolo esterno. Gli parlava di Dianella. Lo straziava quasi con voluttà. Sapeva che nessun dolore, nessuna ingiustizia, non solo non avrebbero fatto commettere alcunché di male a quel giovine incorruttibile, ma non gli avrebbero neppure strappato una parola acerba dalle labbra, tanto era schiavo della propria bontà e rassegnato a essa! Gli parlava misteriosamente, con frasi smozzicate, quasi per non farlo saziare in una volta sola del proprio dolore. Ninì voleva sapere per qual ragione gli avesse detto che Dianella Salvo non sarebbe stata mai per lui, nemmeno se il padre avesse accondisceso.
– Perché? Eh, caro Ninì… C’è una ragione, una ragione che non è cattiva soltanto per voi!
– Che ragione?
– Non ve la posso dire.
– Cattiva anche per chi?
– Anche per me, Ninì!
– Per lei? – domandava Ninì, stupito.
E lei, sorridendo:
– Sicuro. Voi non la vedete; ma c’è. C’è una relazione tra me, voi e… lei. Che relazione? Che ci può esser di comune tra me e voi? Eppure c’è, Ninì. Io e voi siamo uniti da qualche cosa. Pare impossibile, no? Eppure!
Ninì De Vincentis restava assorto ad almanaccare su quella ragione misteriosa e si struggeva dentro.
Quando Aurelio Costa, introdotto da Liborio, si presentò nel salone, Nicoletta era presso il marito; ma sopravvenne poco dopo e provò un gran piacere nel farsi veder da lui in quella casa principesca, tra gli ossequii e il rispetto di tutti. Don Ippolito s’affrettò a riferirle la notizia della dimostrazione popolare.
– Ora riposa, – diss’ella. – Temo che si turberebbe troppo… Ma, se vogliono…
– No, no, – soggiunse subito il principe. – Si troverà modo d’annunziarglielo domani. Ma sì, credo che don Flaminio, – aggiunse Aurelio Costa, – mi abbia mandato così di fretta a quest’ora, per far sapere lì per lì agli elettori che l’onorevole Capolino e il principe sarebbero stati subito informati della dimostrazione.
– Mi dispiace tanto per lei, ingegnere, – disse allora Nicoletta, – che ha dovuto farsi codesta corsa…
– Ma non lo dica! – la interruppe subito il Costa. – L’ho fatta anzi con piacere.
– Anche perché, scommetto, – interloquì zio Salesio, – lei non era mai stato a Colimbètra, eh? Meravigliosa dimora, caro ingegnere… meravigliosa! Vero paradiso in terra!
Il principe sorrise, chinando lievemente il capo, e invitò Aurelio Costa a rimanere a cena.
Per quella serata Ninì De Vincentis fu lasciato in pace da Nicoletta; ma non gliene fu grato affatto. Aveva preso gusto alla tortura. Fu tutta per Aurelio Costa Nicoletta quella sera. E volle proprio inebriarlo; volle ch’egli interpretasse segretamente tutte le premure e gli sguardi e i sorrisi di lei come un compenso all’incarico ingrato impostogli da Flaminio Salvo, di venire cioè là a Colimbètra ad annunziare il trionfo del marito; e volle che in quel compenso ch’ella gli dava, egli sentisse un sapor di vendetta contro il Salvo stesso, il quale, pur conoscendo i sentimenti di lui, lo aveva mandato lì come un servo. Considerava egli tutti come suoi schiavi venduti? Poteva anche darsi però che questi schiavi alla fine, così provocati, accettassero la sfida e s’intendessero tra loro! Non s’intendevano già? Non c’era già tra loro un accordo, un patto segreto? E gli occhi di Nicoletta Capolino fissi in quelli di lui ora sfolgoravano aizzosi e ardenti, ora s’illanguidivano velati e turbati, quasi nella promessa di un’intensa voluttà. Schiavo, schiavo con lei! si sarebbero vendicati di tutti quei vecchi che volevano tenere schiavi loro due giovani! Per lei, d’ora innanzi, egli avrebbe amata la sua schiavitù; e non avrebbe più pensato di diventar padrone anche se Dianella Salvo gli avesse fatto intendere apertamente il suo amore. Schiavo, schiavo con lei!
Era veramente com’ebro Aurelio Costa, avvampato in volto da una gioja riconoscente verso quella donna, quando, a sera tarda, lasciò Colimbètra. Non sapeva che pensare. Il sangue gli frizzava per le vene, le orecchie quasi gli rombavano. Era ella così, per abito o per natura, lusinghiera con tutti, o per lui unicamente aveva formato quei sorrisi e trovato quegli sguardi e quelle premure? Doveva dubitarne o esserne certo? E se certo, per qual ragione s’era indotta così d’improvviso a tentarlo, a provocarlo, dopo avere opposto, anni fa, un così reciso e sdegnoso rifiuto all’onesta domanda di lui? Se n’era pentita? Stanca, nauseata della parte infame che le aveva assegnato il marito, voleva ribellarsi e vendicarsi, scegliendo per la vendetta chi onestamente un giorno aveva voluto farla sua? Voleva ora dargli questa rivincita sopra colui per il quale lo aveva allora rifiutato? O voleva tendergli un’insidia? Questo sospetto, per quanto gli paresse indegno in quel momento, gli s’era pure insinuato tra le varie ondeggianti supposizioni. Non poteva aver molta stima di lei. Ma quale insidia? Innamorarlo, fargli perdere la testa, fino al punto di suscitar la gelosia di Flaminio Salvo, e farlo cacciar via da questo? Ma non le aveva egli detto che nessuna perdita sarebbe stata per lui, ormai, lasciare il Salvo? E poi, qual interesse avrebbe avuto ad allontanarlo? che ombra le dava? Le ricordava, nella miseria presente, il passato? Ma se lei stessa, stringendogli forte, segretamente la mano, aveva voluto ricordare a lui invece quel passato, per toglier l’ombra di esso fra loro due? E gli era parsa sincera! Sì, franca e sincera! E com’era bella! Qual fascino si sprigionava da tutta la persona di lei! Oh, esserne amato…
Giunto alla villa di Flaminio Salvo, ora silenziosa e buja, Aurelio Costa lasciò nella scuderia il cavallo e salì nello studio, ove il Salvo lo aspettava. Questi notò subito il turbamento, l’animazione insolita nel volto e nelle parole del giovine che si scusava del ritardo per essere stato trattenuto a cena dal principe. Ascoltandolo, lo fissava con acuta investigazione; e, appena Aurelio chinava gli occhi, accentuava un po’ più il solito sorriso, effuso in tutti i lineamenti del volto, che un po’ di stanchezza, quella sera, faceva apparir più floscio.
– Me l’aspettavo, – gli disse, carezzandosi le basette.
– Credetti che… – si provò ad aggiungere Aurelio.
– Ma sì! hai fatto bene, – lo interruppe subito il Salvo. – Che buon’aria porti da fuori! Deve far bene una cavalcata a quest’ora in campagna… Bella serata! Qua si soffoca… Quando sarai vecchio te ne ricorderai…
– Io? – domandò Aurelio, indotto a sorridere dal tono amorevole con cui il Salvo gli parlava, quantunque le parole, dopo le riflessioni fatte nel venire, lo ponessero in sospetto. – Perché?
– Mah… dico, forse… – sospirò il Salvo, accompagnando un’alzata di spalle con un gesto vago della mano. – Veramente, tu ci sei avvezzo… Di giorno, di notte, in giro… Vita mossa, la tua! Ma forse questa gita è stata speciale. Quando siamo vecchi, ci si accendono, così, a lampi, ricordi, visioni lontane di noi stessi quali fummo in certi momenti… e non sappiamo neppure perché quel momento e non un altro ci sia rimasto impresso e, a un tratto, ci si stacchi e guizzi sperduto nella memoria. Era forse un ricordo più ampio, di tutto un brano di vita. S’è spezzato. Resta viva una sola scena, vivo un sol momento, un attimo… E ti rivedrai a cavallo, in una notte serena sotto le stelle… e forse invano ti sforzerai di ricordarti quali pensieri avevi in quel punto in mente, quali sentimenti nel cuore…
– Ma questo avviene anche senz’esser vecchi – osservò Aurelio.
– Non è lo stesso, – rispose il Salvo. – Te n’accorgerai.
E restò un pezzo con gli occhi immobili e fissi senza attenzione. C’era veramente anche nel Salvo, quella sera, non so che di strano, e anche Aurelio lo notò, come se, durante la sua assenza, quegli, lì nello studio austero, se ne fosse stato immerso in pensieri che gli avessero ingenerato una tristezza nuova. Quali pensieri? Certo, se n’era stato coi gomiti su la scrivania e la testa tra le mani, poiché sul capo, calvo su l’occipite, erano scomposti i pochi capelli grigi attorno alla fronte. Aurelio sapeva ch’era profondamente triste il fondo di quell’anima torbida e imperiosa, e che il tratto duro, i modi risentiti e irruenti eran come rigurgiti istantanei di quella tristezza inveterata, nascosta, compressa, inconsolabile. Ma perché si era tanto abbandonato ad essa proprio in quella sera che doveva esser lieto della vittoria?
– Tutti bene laggiù? – domandò il Salvo, riscotendosi. – Lui, lo hai visto?
– No, – rispose Aurelio, dissimulando l’impaccio e il turbamento che forse gli trasparivano sul viso, col timore d’aver mancato a una cosa che doveva fare; e però aggiunse in iscusa, arrossendo: – Perché la signora disse che riposava.
– Su gli allori, eh? – aggiunse il Salvo; quindi, levando il mento e sorridendo apertamente, domandò: – E… dimmi, contenta, lei… la signora?
Aurelio aprì le braccia, e con l’aria di chi si fa nuovo di una cosa:
– Non mi parve, – rispose. – Perché?
– Dev’esser contenta. Va a Roma…
– Già, col marito adesso…
– Deputato, deputato, – concluse il Salvo, dimenando il capo. – Era necessario! Deputato.
E si alzò.
– Vedi, caro mio, quali sono le nostre colpe imperdonabili? Poi ci lamentiamo! In un momento come questo, con un’impresa come quella che abbiamo in animo di tentare, che ci costa già tanti studii, che mi espone già a tanti rischi, ho fatto eleggere deputato Capolino. Proprio l’uomo che mi ci voleva, non ti pare? per parlar forte a Roma, domani, al Ministero dell’industria e del Commercio… Ma era necessario. Vedrai che Ignazio starà benissimo a Roma: è il posto suo, quello. Qua m’ingombrava… Piazza pulita, piazza pulita… Caso mai,, andrò io a parlare col signor Ministro, a Roma. Bisogna però che prima qua sottoscrivano tutti i produttori di zolfo, grossi e piccini; li voglio tutti; e con questo, che limitino, occorrendo, l’estrazione del minerale e lo depositino tutto nei magazzini generali. Se no, niente. Arrischio i miei capitali per la salvezza dell’industria siciliana. Ho diritto di pretendere l’unione e l’accordo di tutti gl’interessati e qualche lieve sacrifizio, se occorre. Intanto, mentre qua si studia sul serio per portar rimedio a questa condizione di cose disperata per tutti, hai sentito a Grotte? Vogliono imporsi col numero… Stupidi! Imporsi a chi, e perché? la rovina, oggi, è più per chi ha, che per chi non ha! Il numero… Che forza può avere il numero? Ti può dar l’urto bestiale; ma la valanga che atterra, si frantuma anch’essa nello stesso tempo. Ah che nausea! che nausea! A uno a uno, hanno paura, capisci? e si raccolgono in mille per dare un passo che non saprebbero da soli; a uno a uno, non hanno un pensiero; e mille teste vuote, raccolte insieme, si figurano che l’avranno, e non s’accorgono che è quello del matto o dell’imbroglione che le guida. Questo, là. E qua? Qua un altro spettacolo, più nauseante. Io forse invecchio, Aurelio.
– Lei?
– Invecchio, sì; perdo il gusto di comandare. Me lo fa perdere la servilità che scopro in tutti. Uomini, vorrei uomini! Mi vedo attorno automi, fantocci che devo atteggiare così o così, e che mi restano davanti, quasi a farmi dispetto, nell’atteggiamento che ho dato loro, finché non lo cambio con una manata. Soltanto di fuori però, capisci? si lasciano atteggiare! Dentro… eh, dentro, restano duri, coi loro pensieri coperti, nemici, vivi solamente per loro. Che puoi su questi? Docili di fuori, miti, malleabili, visi ridenti, schiene ossequiose, t’approvano, t’approvano sempre. Ah, che sdegno! Vorrei sapere perché mi arrovello così; perché e per chi lo faccio… Domani morrò. Ho comandato! Sì, ecco: ho assegnato la parte a questo e a quello, a tanti che non hanno mai saputo veder altro in me che la parte che rappresento per loro. E di tant’altra vita, vita d’affetti e di idee che mi s’agita dentro, nessuno che abbia mai avuto il più lontano sospetto… Con chi vuoi parlarne? Sono fuori della parte che devo rappresentare… Certe volte, a qualcuno che viene qua a visitarmi, a incensarmi, mi diverto a rivolgere certi sguardi, certi sguardi che sfondano la parete, e me lo vedo allora per un attimo, restar davanti sospeso, impacciato, goffo; Dio sa che forza devo far su me stesso per non scoppiargli a ridere in faccia. Mi crederebbe ammattito, per lo meno. E anche tu, caro mio, se vedessi con che occhi mi stai guardando in questo momento…
– Io no! – disse subito Aurelio, riscotendosi.
Flaminio Salvo rise, scotendo il capo:
– Anche tu, anche tu… È così; per forza è così… Ti posso io dire quel che vorrei veramente da te? il piacere che mi faresti, se tu agissi com’io forse al tuo posto agirei?
– E perché no? – domandò Aurelio, levandosi. – Mi dica…
– Ma perché no, – negò subito il Salvo, stringendosi nelle spalle, – perché non posso… Puoi dirmi tu quel che pensi, quel che senti, la vita che hai dentro in questo momento?.. Non puoi… Sei davanti a me nelle relazioni che possono correre fra me e te: tu sei il mio ingegnere, il mio buon figliuolo che amo, a cui questa sera, davanti a una ventina di marionette, ho dato l’incarico di recarsi a Colimbètra, messaggero di trionfo: e basta! Che altro potrei dirti? Questo soltanto, forse, per il tuo bene…
E Flaminio Salvo posò una mano sulla spalla di Aurelio:
– Non ti tracciar vie da seguire, figliuolo mio; né abitudini, né doveri; va’, va’, muoviti sempre; scrollati di tratto in tratto d’addosso ogni incrostatura di concetti; cerca il tuo piacere e non temere il giudizio degli altri e neanche il tuo, che puoi stimar giusto oggi e falso domani. Conosci don Cosmo Laurentano? Se sapessi quanta ragione ha quel matto! Va’, va’, è tardi; andiamo a dormire. Addio.
Sceso nel viale della Passeggiata, sotto gli alberi spioventi, nell’ampio silenzio della notte, Aurelio Costa ebbe l’impressione di non trovar più se stesso in sé, e si fermò come per cercarsi. I pensieri che lo avevano agitato intorno al suo avvenire, per quel vasto disegno del Salvo; gli sguardi provocanti, le parole e le premure di Nicoletta Capolino, poc’anzi, a Colimbètra; e qua, adesso, questo discorso triste, sinuoso e inatteso del Salvo, gli avevano quasi disperso, sparpagliato lo spirito. Una parte era rimasta là a Colimbètra; l’altra qua nella villa. Frastornato, messo in sospetto, ripensava alle parole del Salvo. E dunque sarebbe andata a Roma Nicoletta? E allora? Ma come? Il Salvo s’era voluto sbarazzare del Capolino: Sì, lo aveva detto chiaramente: Piazza pulita. Aveva alluso fors’anche a lei? C’era una certa ironia nella domanda che gli aveva rivolta: Contenta, la signora? Aveva voluto allontanare anche lei dalla sua casa? O forse ella gli si era ribellata? Era egli così triste, in un animo così insolito, per questo? E che voleva da lui? Che senso cavare dalle strane cose che gli aveva dette? Ti posso io dire il piacere che mi faresti, se tu agissi com’io forse al tuo posto agirei?Che piacere? che aveva inteso dire? Un desiderio segreto, inconfessabile? O aveva detto così, in genere? S’era lamentato d’aver attorno automi, fantocci… E quei consigli, in fine. Per quanto si sforzasse, non riuscì a raccapezzarsi. E allora, quasi lasciando fuori, a vagar dove volevano, pensieri e dubbii e sospetti, si restrinse nel guscio sicuro della sua coscienza, nel sentimento modesto, tranquillo e solido che aveva sempre avuto di sé. Per il caso fortuito d’aver cavato, un giorno, quasi senza volerlo, dalle mani della morte il Salvo, era stato sollevato a una condizione invidiabile, di cui con le sue stesse doti naturali, e la buona volontà, aveva poi saputo rendersi degno. Il favore stesso della fortuna, che tutti riconoscevano meritato, l’eco ingrandita degli onori a cui era venuto negli studii, nei concorsi, nella professione, gli avevano dato di poi un’importanza che egli stesso riconosceva soverchia, e che lo metteva qualche volta in imbarazzo. Il modo con cui si vedeva accolto e trattato, quel che si diceva di lui, gli dimostravano di continuo ch’egli era per gli altri qualcosa di più che per se stesso; un altro Aurelio Costa, ch’egli non conosceva bene, di cui non si rendeva ben conto; restava perciò sempre innanzi agli altri in uno stato d’animo angustioso, in una strana apprensione confusa, di venir meno all’aspettativa altrui, di decadere dalla sua reputazione. Sapeva star bene al suo posto, ma avrebbe voluto starci quieto e sicuro; invece gli pareva che gli altri, avendo egli preso a salire fin da ragazzo, gli indicassero ancora come a lui pertinente un posto più alto, e lo spingessero e non lo lasciassero star tranquillo. Non era timidezza la sua; era un ritegno impiccioso, che spesso lo irritava contro gli altri o contro se stesso, una costernazione assidua che si scoprisse in lui qualche manchevolezza, se appena appena si fosse allontanato dal campo delle sue conoscenze, ove si sentiva sicuro, dal posto, ove poteva stare, ov’era arrivato da sé per suo merito effettivo. La irritazione contro se stesso nasceva anche dal veder che tanti, da lui stesso stimati inferiori in tutto, sapevano farsi avanti con disinvoltura ed erano lasciati passare; mentre lui, ritenuto dà tutti superiore anche al concetto ch’egli aveva di se medesimo, lui si tirava indietro e, se spinto, si sentiva spesso impacciato nei movimenti, nel parlare, e arrossiva talvolta come una fanciulla.
Quella sera, Aurelio Costa avvertì più che mai quel senso di inesplicabile fastidio che gli cagionava sempre la propria ombra nell’allungarsi sperticatamente, assottigliandosi innanzi a lui, a mano a mano che si allontanava dai lampioni accesi. Dopo il frastuono della dimostrazione popolare, il silenzio della città addormentata, vegliata da quei lugubri lampioni, gl’incuteva ora una cupa ambascia.
A metà della via Atenea deserta, scorse Roberto Auriti, solo; si voltò a guardarlo con profonda pena e lo seguì con gli occhi finché non lo vide svoltare per una delle erte viuzze a manca che conducevano alla Badia Grande.
Tutta quella notte si vegliò in casa di donna Caterina Laurentano, dovendo Roberto e il nipote partire a bujo, alle quattro del mattino. La vecchia casa era ancora illuminata a petrolio, e s’andava col lume in mano da una stanza all’altra.
Anna Del Re s’indugiava amorosamente negli ultimi preparativi per il figliuolo. Che strazio, per lei, quella partenza! Tutto il suo mondo, tutta la sua vita, da anni e anni, erano raccolti nell’amore e nelle cure per quel suo unico bene. Come avrebbe vissuto più ora senza di lui? E piangeva silenziosamente.
Se l’era allevato, lo aveva custodito con l’anima e col fiato, non badando ai rimproveri della madre che temeva lo avviziasse troppo. Ma no, no! che avviziare! Era tanto impensierita e tormentata, lei, nel vederlo crescere così freddo e arcigno, sempre e tutto chiuso in sé, e procurava con le sue maniere, con le cure sempre vigili, d’addolcirlo, ecco, di riscaldarlo con l’amore materno, di renderlo più espansivo e confidente.
Non sapeva che cosa egli covasse in fondo al cuore, che lo allontanava anche dalla compagnia dei giovani della sua età. Studiare, studiava anche troppo, con nocumento finanche della salute; e quando non studiava, stava acutamente assorto in certi pensieri che gli rendevano più irsute le ciglia, più duro e scontroso lo sguardo dietro le lenti da miope.
– Oh Dio, Ninuccio, se vedessi come ti fai brutto…
Egli le rispondeva con una spallata.
Forse soffriva, il suo Ninuccio, delle angustiose condizioni della famiglia, forse pensava che la nonna anche senza derogare affatto a se stessa, ai suoi sentimenti, avrebbe potuto essere ricca. Troppo, certo, l’infanzia di lui e la prima giovinezza erano state aduggiate dall’ombra cupa di tante sventure in quella vecchia e vasta casa sempre silenziosa, nella quale il sole, entrando, pareva non recasse mai né luce né calore. Che casa! Lo notava quella notte, presentendo lo squallore in cui domani le sarebbe apparsa! Logorati i mobili, anneriti i soffitti, consunto il pavimento, inaridite e stinte le cornici delle imposte, sbiadita in tutte le stanze la carta da parato. Pur curata e pulita e rassettata sempre, pareva che anch’essa sentisse oscuramente la doglia della vita. Aveva ragione Corrado Selmi; aveva interpretato bene il segreto sentimento di lei… Già da tempo rassegnata, avrebbe desiderato, se non per sé, almeno per quel figliuolo, che alla fine qualche sorriso di pace alleviasse un po’ l’oppressione delle memorie dolorose, quel cupo rancore contro la vita, la muta, disperata amaritudine della madre.
Calma, e non pace! Non poteva aver pace l’anima di donna Caterina Laurentano. Forse perché non credeva più in nulla? Lei sì, Anna, credeva; credeva fervidamente in Dìo, pur senza seguire alcuna delle pratiche religiose. Le donne del vicinato non la vedevano mai andare a messa, come la madre; e tuttavia distinguevano tra l’una e l’altra, indovinavano che la signora giovane era religiosa e, nell’intravederla qualche volta da lontano, così bella e mite, sempre vestita di nero, se l’additavano come una santa.
Anna stava soprattutto in pensiero per la nuova vita, in mezzo alla quale si sarebbe trovato fra poco il figlio nella casa del fratello, a Roma. Non dubitava che Roberto avrebbe avuto le più diligenti cure per il nipote; ma la donna ch’egli aveva con sé? i parenti, gli amici? quel Corrado Selmi che, col suo fascino strano, era finanche riuscito a turbar lei? Chi sa quale impressione ne avrebbe ricevuto il suo Ninuccio, vissuto sempre qua, rinchioccito presso lei e la nonna! L’una e l’altra avevano parlato spesso e a lungo, con amarezza, della vita mancata del loro Roberto, della falsa famiglia che s’era formata, su le notizie che ne aveva dato loro Giulio, l’altro fratello; notizie piuttosto vaghe, perché Giulio, cresciuto sempre a Roma, aveva perduto del tutto l’aria, il sentimento della famiglia, non pareva più affatto neanche siciliano; e forse scusava il fratello maggiore; certo non dava alcun peso, alcuna importanza a tante cose che per poco a lei e alla madre non facevano orrore.
Era una maestra di canto, moglie d’un tenore che aveva perduto la voce, la compagna di Roberto. E Giulio aveva detto, ridendo, che questo tenore, buon uomo, sedeva ogni giorno alla tavola di Roberto e dormiva poi, la sera, presso un fratello della moglie che teneva una specie di collegio, di conservatorio di musica privato, dove colei insegnava canto e il marito fungeva nientemeno che da censore. Roberto era come in pensione in quella casa, dove qualche volta, nelle annate di maggiore affluenza, alloggiava anche qualche convittore che non aveva trovato posto nel collegio del fratello. A contatto di tal gente si sarebbe trovato dunque, tra poco, il figliuolo. Parecchie volte Anna aveva cercato di persuadere la madre di proporre a Roberto il loro trasferimento a Roma. Avrebbero venduto quella casa, albergo di tante sventure, e si sarebbero accomodate a vivere alla meglio a Roma, magari sole dapprima, sole o con Giulio soltanto. Chi sa che, a poco a poco, col tempo, la madre non sarebbe poi riuscita a liberar Roberto da quella compagnia… Non sarebbe stato anche un risparmio, di tre case farne una sola? E tutta la famiglia raccolta insieme…
– Sogni! – le aveva detto la madre. E non aveva voluto neanche mettere in discussione la proposta.
Sapeva che né Giulio avrebbe voluto perdere la propria libertà, né Roberto avrebbe saputo sciogliersi dalla schiavitù di quella donna. Anche lei, poi, all’età sua, non avrebbe potuto resistere a un cambiamento così radicale di vita e d’abitudini.
– Sogni! Quand’io morrò, e Nino sarà cresciuto, tu andrai con lui… Ci penserà lui a farti una nuova vita.
– Ma intanto!… – sospirava Anna, e guardava nell’altra stanza il figlio, che ascoltava i discorsi della nonna e dello zio, con una mano tra i capelli, un gomito su la tavola, sotto la lampada che pendeva dal soffitto. Eccolo: non dimostrava né pena d’allontanarsi da lei per circa un anno, né gioja di recarsi a Roma. Sempre così! Una volta sola su i primi dello scorso anno, infatuato d’una scoperta che credeva d’aver fatto, d’un suo speciale congegno per trarre – diceva – l’energia elettrica dalle onde del mare (era venuto, quell’anno, all’istituto Tecnico un bravo professore di fisica, il quale era riuscito a infervorare per la sua scienza tutti gli scolari) le aveva parlato con vero calore, per indurla a spingere la nonna a chiedere in prestito qualche migliajo di lire, – non allo Zio Borbonico, no! – ma allo zio Cosmo, magari: un migliajo di lire in prestito, per costruire alla meglio gli attrezzi necessarii agli esperimenti che si sarebbe recato a fare a Valsanìa, su la piaggia. Povero figliuolo! Gli aveva fatto cascar le braccia, subito. La nonna? chieder denaro in prestito ai fratelli? E non la conosceva? S’era subito rinchiuso nel suo ispido silenzio, e non aveva voluto darle nemmeno una spiegazione su quella sua famosa scoperta. Chi sa quanto c’era di vero… Forse un’illusione puerile! Ma pure, tutto quell’anno, aveva seguitato a studiare accanitamente quella scienza, e ora, andando a Roma, si proponeva di dedicarsi a essa interamente. Altri affetti – pur essendo così giovane – altre cure, altre voglie pareva non avesse.
– Ninuccio, – chiamò.
Aveva finito di preparare la valigia, e voleva l’ajuto di lui, per chiuderla. Egli accorse subito.
– Troppo piena? – gli domandò. – Hai voluto metterci tutti quei libri… Non sarebbe meglio levarli di qua e porli insieme con gli altri nella cassetta? Tanto, te la spediremo subito.
– Me la porto via con me, la cassetta, – diss’egli. – Non mi fido. Chi sa quando m’arriverebbe…
– Ma ti peserà troppo, figlio mio, che dici? Impossibile… Non dubitare, l’avrai subito. Ci penserò io…
– E allora qua nella valigia, lasciali qua, questi libri. Chiudo?
– Non ha detto nulla la nonna di là, a zio Roberto? – domandò lei allora, alludendo a quella sua proposta.
– Nulla, – rispose il figlio.
– Capisco anch’io, – sospirò Anna, – che è quasi impossibile… L’avrei voluto per te… Mah! Ninuccio mio, mi raccomando: mi devi scrivere tutto, sempre… se hai bisogno di qualche cosa… come stai… se ti trovi bene… Tutto! Mi contento anche di poche righe… Ma le prime lettere, no, sai? lunghe, le prime lettere… Voglio saper tutto! E bada, Ninuccio… un po’ più d’ordine! Ti disporrai bene tutta la biancheria nei cassetti… Non fare al solito tuo! Zio Roberto è molto ordinato, lo sai… Ordinato anche tu! E non ti dico altro… So che farai il tuo dovere e che contenterai tua madre e la nonna, che restiamo qua… sole… Basta, basta… Presto sarà l’ora…
Entrarono nella sala da pranzo, dove la nonna e Roberto sedevano accanto sul canapè.
– Vedrai, – diceva donna Caterina. – Io vorrei prima finir di chiudere questi occhi. Ma toccherà forse di vedere anche a me, per conchiudere bene, questo spettacolo qua. Ci sarà, non dico, chi mette male apposta; ma alla mala semenza il terreno è preparato da anni. Voi state a Roma, e non sentite e non vedete nulla. Vorrei ingannarmi! Ma non m’inganno.
Alzò il capo a guardar la figlia e il nipote, vide negli occhi di Anna le lagrime, ed esclamò, levando un braccio:
– Lascialo partire, lascialo andar via! Aria! Aria! Respirerà… Buca l’uovo, figliuolo mio; e lascia star qua nojaltri, ad aspettare la manna del cielo! Nel Sessanta, caro Roberto, sai che facemmo noi qua? sciogliemmo in tante tazzoline le animucce nostre, come pezzetti di sapone; il Governo ci mandò in regalo un cannellino per uno; e allora noi qua, poveri imbecilli, ci mettemmo tutti a soffiare nella nostra acqua saponata, e che bolle! che bolle! una più bella e più variopinta dell’altra! Ma poi il popolo cominciò a sbadigliare per fame, e con gli sbadigli, addio! fece scoppiare a una a una tutte quelle magnifiche bolle che sono finite, figlio mio, con licenza parlando, in tanti sputi… Questa è la verità!
La serva venne ad annunziare che la carrozza era arrivata e che il vetturino, un po’ in ritardo, faceva fretta. C’era circa mezz’ora di vettura da Girgenti alla stazione ferroviaria in Val Sollano.
Anna, con la candela in mano innanzi alla porta, presso la madre, rimase come sopraffatta, insaziata dell’ultimo abbraccio frettoloso al figlio, che correva accanto allo zio, giù per la ripida viuzza a scalini, nel bujo ancor fitto.
«Figlio mio! figlio mio!», gemeva tra sé.
– Tu, Ninuccio, lo rivedrai, – le disse piano la madre. – Io, Roberto… chi sa!
Udirono nel silenzio profondo il rotolìo della vettura che s’allontanava. E Anna levò gli occhi pieni di lagrime al cielo, dove le stelle, per lei, vegliavano religiosamente.
««« Capitolo 7 Parte II – Capitolo 1 »»»
| I vecchi e i giovani – Indice Introduzione |
|
| Parte I
Capitolo 1 |
Parte II
Capitolo 1 |
««« Introduzione ai romanzi di Luigi Pirandello
Se vuoi contribuire, invia il tuo materiale, specificando se e come vuoi essere citato a
collabora@pirandelloweb.com