Di Donatella Orecchia.
Luigi Pirandello nasce a Girgenti nel 1867; Silvio d’Amico (vedi biografia) a Roma nel 1887.
Della stessa generazione di Benedetto Croce, di Gabriele D’Annunzio, di Svevo e De Roberto; un po’ più vecchio di Martoglio e di Butti, coetaneo di Irma Grammatica e con qualche anno in più rispetto a Ruggero Ruggeri e Angelo Musco, Pirandello appartiene a quella generazione che, nata negli anni sessanta dell’Ottocento, non aveva conosciuto le battaglie, le conquiste e le speranze risorgimentali: “erano nati che già l’Italia era fatta, ed erano ragazzi quando le prime ventate scapigliate e poi di Positivismo e Realismo erano arrivate da noi […].

Silvio d’Amico e Luigi Pirandello:
frammenti di un incontro (1918-1936)
E si erano formati tra le convulsioni della Nuova Italia: il brigantaggio, il passaggio dalla Destra storica alla Sinistra, il trasformismo, le lotte sociali, Crispi; e le crisi del nuovo decennio [gli anni novanta] li coglievano a trent’anni, alcuni ancora più giovani” (1)
(1) G. Petronio, Romanticismo e verismo. Due forme della modernità letteraria, Milano, Mondadori, 2003, p. 381.

Anche Pirandello, come gli altri, aveva assistito proprio negli anni di formazione all’inizio del lento ma inesorabile declino della tradizione del positivismo e del naturalismo tardo ottocenteschi; alla fine della fiducia nel progresso scientifico e nelle certezze verificabili; allo sgretolarsi degli ideali e delle speranze che avevano accompagnato i padri durante gli anni del Risorgimento. Allo smarrimento che ne seguì. Vi assistette, come si sa, da un osservatorio molto particolare – fra Sicilia, Roma e Bonn – e, fin dagli anni fra gli ottanta e i novanta, con un forte senso ’estraneità rispetto ai tentativi di fornire nuove risposte, da un lato, da parte del decadentismo d’annunziano e, dall’altro, del neoidealismo crociano.
D’Amico, quasi coetaneo di Palazzeschi, di Petrolini, di Tofano, un po’ più giovane di Tozzi, di Gozzano e di Prezzolini, un po’ più vecchio di Gramsci, di Gobetti e di Bragaglia, appartiene a quella generazione che, maturata in epoca giolittiana, da principio resa compatta nell’opposizione insofferente verso la cultura positivistica di fine secolo, nell’attrazione per il nuovo idealismo di Croce e di Gentile, per il pensiero di Sorel e di Bergson, sarà protagonista dei fermenti e delle rivolte degli anni dieci, ma si scompaginerà poi negli anni immediatamente precedenti alla prima guerra mondiale, rivelando solo nell’‘ora del pericolo’ le diverse anime che l’avevano nutrita (2).
(2) R. Luperini, Controtempo, Critica e letteratura fra moderno e postmoderno: proposte, polemiche e bilanci di fine secolo, Napoli, Liguori, 1999, pp. 43-44.
Anche d’Amico, romano di nascita, per tradizione famigliare e per formazione culturale, parteciperà a modo suo a quel fermento, da principio avvicinandosi alla corrente del modernismo cattolico (3) che, se da un lato rappresentò un reale tentativo di rinnovamento interno alla Chiesa di inizio secolo, dall’altro andava in direzione opposta ai fermenti culturali e artistici degli anni a cui stiamo facendo riferimento per quel suo mostrarsi attenta e sensibile alle provocazioni provenienti dal mondo delle scienze.
(3) Per quanto riguarda la storia degli anni giovanili e universitari si veda l’articolo di Andrea Mancini, Gli anni giovanili, in “Ariel”, settembre-dicembre 1987.
Ma già a partire dal 1916, recuperate fra l’altro posizioni religiose più ortodosse, d’Amico si incontrava con la più diffusa insofferenza nei confronti del positivismo tardo ottocentesco.
Dal momento del loro incontro ufficiale (nel 1918, cioè, al tempo dei primi interventi del giovane critico sull’ “Idea nazionale”) e per i vent’anni successivi, i percorsi di Pirandello e d’Amico si incroceranno, influenzando come pochi altri in quel periodo la scena teatrale italiana e testimonieranno, fra l’altro, quella vivace e feconda dialettica fra generazioni, sguardi e prospettive diverse che caratterizzò il nostro panorama culturale ancora per buona parte degli anni venti e che poi tenderà ad appiattirsi e normalizzarsi, come l’intero contesto culturale e politico, nel corso degli anni trenta.
Non sarà certo qui possibile rendere conto di tutta questa lunga storia. Ci limiteremo a focalizzarne alcuni punti particolarmente significativi cogliendo, per quanto possibile, continuità e discontinuità di un percorso.
1.
Il primo intervento di Silvio d’Amico su Pirandello, dal titolo Teatro recente, compare sull’“Idea Nazionale” nel maggio del 1918 (4), quando hanno ormai visto la luce alcuni dei capolavori drammatici dello scrittore del periodo ‘umoristico’ – Se non così, All’uscita,Il piacere dell’onestà e Così è (se vi pare)– e molte delle opere di quei drammaturghi che, come si sa, presto verranno raccolti sotto la denominazione di ‘grotteschi’(fra le altre anche Marionette, che passione! di Rosso di San Secondo a cui è riservata la seconda parte dell’articolo di d’Amico).
(4) S. d’Amico, Teatro recente, in “Idea nazionale”, 3 maggio 1918.
A questo intervento segue, nell’ottobre dello stesso anno, un pezzo scritto in occasione della prima del Piacere dell’onestà (Compagnia Ruggeri), in novembre uno in occasione della recita di Così è (se vi pare) (Compagnia Talli) e in dicembre uno per Il giuoco delle parti (Compagnia Ruggeri).
Sono evidenti, nell’impostazione metodologica e nei conseguenti giudizi critici di questi primi interventi, due aspetti fondamentali della prospettiva a partire dalla quale il giovane d’Amico interpreta l’arte contemporanea che caratterizzeranno l’intero suo percorso intellettuale: da un lato, una fortissima tensione militante e, dall’altro, un modo molto preciso di guardare alla storia, in cui cattolicesimo e idealismo di matrice crociana s’intrecciano condizionandosi a vicenda. L’idea di una storia intesa come svolgimento, come progressiva rivelazione di uno spirito umano secondo una prospettiva che Gramsci a proposito di Croce definì teleologica (5), si incontra coniugandosi con un cattolicesimo culturalmente conservatore.
(5) Si vedano a questo proposito le pagine di Antonio Gramsci sul carattere teologico-speculativo dello storicismo idealistico di Croce. Nonostante le dichiarazioni in merito del suo autore, infatti, la filosofia di Croce rimane “una filosofia ‘speculativa’ e in ciò non è solo una traccia di trascendenza e di teologia, ma è tutta la trascendenza e la teologia, appena liberate dalla più grossolana scorza di mitologia”: A. Gramsci, La filosofia di Benedetto Croce, in Id., Il materialismo storico, Torino, Editori Riuniti, 1979, pp. 237.
Da ciò deriva, fra l’altro, la consuetudine sua a liquidare, a priori e sotto la pressione della propria idea del progresso, quanto del passato non vi rientri, quanto talvolta, invece, di quel passato permane ancora concretamente vivo nel presente. Perché “il passato è cosa complessa, un complesso di vivo e di morto, in cui la scelta non può essere fatta arbitrariamente, a priori, da un individuo o da una corrente politica” (6).
(6) Sono ancora parole di Gramsci sempre su Benedetto Croce: “In realtà, se è vero che il progresso è dialettica di conservazione e innovazione e l’innovazione conserva il passato superandolo, è anche vero che il passato è cosa complessa, un complesso di vivo e di morto, in cui la scelta non può essere fatta arbitrariamente, a priori, da un individuo o da una corrente politica […]. Ciò che del passato verrà conservato nel processo dialettico non può essere determinato a priori, ma risulterà dal processo stesso, avrà un carattere di necessità storica”: A. Gramsci, La filosofia di Benedetto Croce, in Il materialismo storico e la filosofia di Benedetto Croce, Roma, Editori Riuniti, 1971, p. 263.
Dalla passione militante deriva il modo conflittuale con cui d’Amico si inserisce fin da principio all’interno del dibattito del tempo e la necessità di individuare ben presto e con precisione il nemico di quella battaglia; da quell’idea di storia dipende la consuetudine a dichiarare morto preventivamente il nemico che, eliminato così virtualmente –sebbene nella concretezza dei fatti talvolta ancora presente–, lascia libero il critico di invocare, talvolta un po’ astrattamente, l’aprirsi di nuove e diverse prospettive.
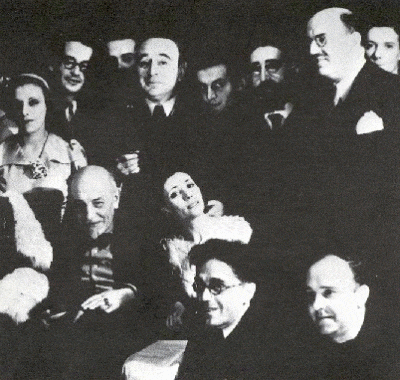
Ecco che, all’altezza del 1918, il nemico denunciato morto, dalla cui presenza si deve sgomberare il campo per uscire finalmente dalla crisi del sistema teatrale, è per d’Amico già assolutamente chiaro: da un lato, il grande attore e con lui l’intero sistema teatrale ottocentesco –di qui gli attacchi a Novelli e a Zacconi, in particolare, in quanto rappresentanti illustri di quella tradizione; illustri e vivi, e nel pieno della loro attività artistica almeno il secondo (7) –; dall’altro, la cultura del realismo positivista, gretto, grigio, privo di ideali –che va dalla commedia borghese milanese (Marco Praga), a Ermete Zacconi – (8).
(7) Si ricordi in particolare l’ampio articolo su Ermete Novelli del novembre 1914, Novelli se ne va, in “L’Idea Nazionale”, 30 novembre 1914. Gli articoli del critico su Ermete Zacconi sono moltissimi, a partire dal 1916 fino ad arrivare alla famosa polemica sul grande attore del 1930, scatenatasi sulle pagine della “Gazzetta del popolo” all’indomani della pubblicazione del Tramonto del grande attore. In quell’occasione, da questo punto di vista emblematica, Zacconi svolge il ruolo non solo di antagonista, ma di rappresentante emblematico di una storia (quella del teatro del grande attore ottocentesco) che d’Amico intende dichiarare conclusa definitivamente. Pertanto si trova a difendere non solo la propria poetica specifica d’attore, ma anche la legittimità stessa di un’arte d’attore, ossia la legittimità stessa della propria esistenza. La polemica inizia con un articolo di Zacconi (Ermete Zacconi difende il “grande attore” contro coloro che lo vorrebbero morto e sepolto, 14 dicembre 1930) a cui d’Amico ribatte quattro giorni dopo con un pezzo dal titolo Polemica col grande attore (Silvio d’Amico risponde a Ermete Zacconi), 18 dicembre 1930; seguono ancora un articolo di Zacconi (Non c’è grande teatro senza il grande attore) del 23 dicembre e uno di d’Amico (La polemica sul grande attore, del 27 dicembre) che chiude la polemica.
(8) S. d’Amico, Teatro vecchio e nuovo (A Marco Praga e a Lucio d’Ambra), in “L’idea nazionale”, 14 dicembre 1921; Id., La commedia borghese. Risposta a Marco Praga, in “L’idea nazionale”, 6 dicembre 1921. Si tratta di una polemica molto diffusa in Italia in quegli anni condivisa dalla maggior parte degli intellettuali della generazione di d’Amico. In campo teatrale, trova soprattutto in Piero Gobetti un altro agguerrito promotore, di cui si vedano a questo proposito le pagine durissime contro Ermete Zacconi.
È chiaro che, da questo punto di vista, Pirandello è per d’Amico un alleato su un duplice fronte: nella lotta contro realismo borghese ottocentesco e nella lotta contro lo strapotere del grande attore. Entrambi hanno assistito al tramonto della fiducia nella scienza come sapere assoluto propria del positivismo, che già nel 1905 Benedetto Croce aveva definito “stremato” e “ridotto presso a morte” (9) e alla fine di un modo di guardare la realtà e l’arte che avevano caratterizzato buona parte del secolo precedente.
(9) B. Croce, A proposito del positivismo italiano [1905], in Id., Cultura e vita morale. Intermezzi polemici, Bari, Gius. Laterza & Figli, 1955 [1° ed. 1913], p. 46.
Entrambi in quel periodo guardano il teatro dal punto di vista del testo letterario e, per entrambi, la scena è una “necessità pratica”, che ineluttabilmente tradisce la concezione dell’autore. “L’interpretazione scenica è impresa disperata:
/ il suo fascino è nella sua impossibilità / e nella gioia che […] può dare” (10): così appunterà d’Amico anni più tardi, sottolineando l’impossibilità dell’interpretazione fedele e, contemporaneamente, il fascino e la gioia che da lì, proprio da lì, derivano.
(10) L’appunto appartiene a un documento manoscritto, in parte illeggibile, che dovrebbe essere stato la traccia preparata da d’Amico per un discorso orale: Fondo d’Amico del Civico Museo Biblioteca dell’Attore di Genova, Cartella “Conferenze”, faldone 3-4, Teoria e pratica dell’attore, cart. IV, n. 6.
E Pirandello, che avrebbe potuto sottoscrivere, ha sempre sperimentato qualcosa di simile anche prima di iniziare la sua attività di direttore al Teatro d’Arte (11).
(11) Sul rapporto contraddittorio di Pirandello con la scena, sia nelle sue riflessioni teoriche, sia nel contatto diretto con la vita teatrale (in particolare con gli attori) la bibliografia è molto ampia: ricordiamo almeno A. d’Amico, Pirandello, l’attore, gli attori, in AA.VV., Alle origini della drammaturgia moderna: Ibsen, Strindberg, Pirandello. Atti del convegno internazionale, Torino, 18-20 aprile 1985, Genova, Costa & Nolan, 1987; C. Vicentini, Il modello della recitazione naturalistica nella drammaturgia di Pirandello, in “Il castello di Elsinore”, n.1, 1988; U. Artioli, Pirandello e la régie, in AA. VV., Pirandello e il teatro, Palermo, Palumbo, 1985; AA. VV., Pirandello tra scrittura e regia, Numero monografico di “Quaderni di teatro” a cura di R. Tessari, novembre 1986; I. Pupo, Trabocchetti all’Odescalchi: due articoli dimenticati di Pirandello capocomico, in “Biblioteca teatrale”, ottobre-dicembre 1999.
Entrambi, insomma, paiono come tirati da quella necessità pratica a cui guardano con moti contraddittori e oscillanti, con ostilità ma anche con curiosità, con diffidenza e con interesse. Entrambi, ed è forse ciò che più li avvicina, tanto impegnati a sostenere il tradimento della scena e dell’attore rispetto alla scrittura, quanto richiamati alla vita del palcoscenico.
Nonostante ciò, le perplessità di d’Amico su Pirandello sono molte e già in questo primo articolo individuate con precisione.
La questione fondamentale da cui partire per fare chiarezza è certamente il diverso modo di intendere e di esprimere la crisi storica di cui sono attenti testimoni: in estrema sintesi, il crollo dei parametri d’interpretazione del mondo sia della tradizione illumistico-positivista, sia di quella romantico-risorgimentale e le conseguenze che ciò comportò nell’Europa fra la fine dell’Ottocento e gli inizi del nuovo secolo.
Da anni Pirandello, fin dal suo Arte e coscienza d’oggi del 1893, aveva iniziato a riflettere sulla “degenerazione del presente” in cui, ormai “crollate le vecchie norme, non ancor sorte o bene stabilite le nuove”, nessun ideale più “arriva a concretarsi davanti a noi in un desiderio intenso veramente, o in un bisogno forte”, tanto che la vita appare nella sua vanità e la lotta nella sua inutilità (12), mentre la coscienza assume l’aspetto di “un sogno angoscioso, attraversato da rapide larve or tristi or minacciose, d’una battaglia notturna, d’una mischia disperata” (13).
(12) L. Pirandello, Arte e coscienza d’oggi [1893], in Id., Saggi, poesie e scritti varii, Milano, Mondadori, 1977, p. 903.
(13) Op. cit., p. 906.
La condizione cosciente, propria del poeta umorista, è la condizione di chi vive in questo sogno angoscioso, risultato del crollo non solo della fede nella scienza come sapere assoluto, ma insieme della fiducia nell’evoluzione positiva della storia, dell’ideale di una conoscenza di leggi che regolino la realtà, nel potere del soggetto di dare senso unico e coerente al mondo, dell’arte di esprimere ancora una Verità.
La condizione cioè di chi vive fino in fondo nella crisi, senza abbandonarsi alla rassegnazione cinica o nichilista, né al relativismo assoluto; piuttosto denunciando lo stato paradossale dell’uomo e dell’artista, dell’impossibile verità nella permanenza, tuttavia, del ‘problema della verità’; nella nostalgia rabbiosa per la verità perduta. Per i beni perduti, infatti, “quando non si prova nostalgia si prova odio e rancore”, ricordava Giacomo Debenedetti proprio a proposito di Pirandello e della sua produzione narrativa. Qui, appunto, “la vendetta contro il naturalismo e il suo mondo” diviene furore che investe lo stesso cerebralismo delle trovate, che è un modo dispotico, dittatoriale di disporre del materiale narrativo, proprio perché questo ha perduto la sua razionalità: la sua organica consequenzialità, la sua facoltà di presentarsi con naturalezza, come una ‘tranche de vie’, un brano di vita prelevato dalla vita, la quale avrà le sue pazzie e aberrazioni, ma tali che rientrano nella logica delle cose, come si dice, e nell’ordine delle cose. Le trovate di Pirandello invece rientrano in un’altra logica (14).
(14) G. Debenedetti, Il romanzo del Novecento, Milano, Garzanti, 1998, p. 262.
D’Amico, invece, che ben conosce la crisi del suo tempo, non se ne sente minacciato, poiché continua a credere in una Verità, non positivistica certo,ma salda e sicura; nella razionalità e nell’organicità del mondo; nello svolgimento progressivo e teleologico della storia; nella Poesia e nell’Arte come espressione di Verità e, di conseguenza, nell’autore-poeta e nella sua funzione sociale di vicario di quella Verità. La crisi, sembra voler dire il critico, si supera, non si vive, anche perché per ragioni d’età d’Amico quella crisi alle sue origini non la visse direttamente, ma ne fu, insieme agli altri della sua generazione, come l’erede; crisi, dunque, come incidente di un percorso passato, non come condizione del presente; tutt’al più temporaneo disagio, non perdita. Insomma, crisi sì, ma con compostezza.
E, invece, l’umorismo di Pirandello scompone con rabbia, affonda in terreni fangosi, fa agire fantocci ‘sconciati’, blocca i suoi burattini in un’unica smorfia a dilaniarsi fissati nelle loro maschere, in quei ruoli cioè che li inchiodano senza possibilità di libertà e redenzione, senza accessi ad un’autenticità di vita. L’umorismo cioè, in quanto poetica della e nella crisi non propone una risoluzione e facili uscite dalla crisi: piuttosto ne denuncia l’esistenza e, insieme, ne descrive i caratteri.
Ecco dunque come d’Amico riesce fin dai primi interventi a ‘fotografare’ i tratti principali dell’opera di Pirandello. E colpisce la sicurezza e la lucidità con cui coglie alcuni degli aspetti più significativi e caratteristici di quella scrittura drammatica fin da questi primissimi interventi, senza aderire tuttavia alla poetica che li ha determinati e senza potere poi, partendo da una prospettiva critica così distante,riconoscere fino in fondo il percorso di ricerca dell’artista.
L’“ironia negatrice” (15), innanzitutto, che d’Amico riconosce essere il dato primo della poetica del drammaturgo, porterebbe lo scrittore ad accanirsi “spietato nel decomporre le apparenze della vita sociale per dissolverne le illusioni e ridere amaro sulla realtà grottesca” e a stravolgere i meccanismi scenici consueti. E pare questa una descrizione perfetta.
(15) S. d’Amico, Teatro recente, cit.
Di qui, continua il critico, l’assenza di una trama e la liquidazione del personaggio tradizionalmente inteso; di qui l’esasperazione di casi patologici dove “la vita non germina spontanea ma è trattenuta e compressa scena per scena”, dove il dialogo si spezza in “accenti rotti e pause ansanti esprimendosi più con quello che lascia intravedere che con quello che dice”, dove i personaggi “non sono uomini ma marionette”. E resta qualcosa “di greve e di opaco”, si sente che ciò che trionfa non è il conflitto di coscienze o situazioni, ma “un contrasto di argomentazioni”, una “dialettica lucida e insaziabile”. Trionfa il ragionamento sui sentimenti, mentre “espedienti tutt’altro che nuovi […] nonostante l’abilità dello scrittore, alla fine fanno sentire la loro falsità”: la falsità di personaggi che “non mostrano ma dimostrano”, di battute dette da uno ma che potrebbero essere indifferentemente dette da un altro, di vecchi artifici ripresi e svuotati dall’interno e ridotti a “meccanismi a molla”.
Su tutto un’ “ironia aspra” e “un pessimismo desolato” (16) che non libera né rinfranca il pubblico, l’assenza totale d’umanità e una compiacenza irritata e quasi rabbiosa.
(16) Tutte le citazioni precedenti sono tratte dall’articolo di d’Amico Teatro recente citato.
D’Amico che sa descrivere con tanta precisione e intuito, non comprende poi la ragione di quei personaggi che derivano dalla scomposizione della persona/personaggio romantico e borghese, dal frantumarsi dell’unità psicologica, dell’identità individuale e sociale e il cui dramma è aver perduto per sempre coerenza e organicità e senso. Personaggi già fatti e finiti, che recano sempre fin dal loro comparire in scena, nel volto e nelle vesti, i segni del loro dramma da cui non potranno liberarsi mai; personaggi, che non sono protagonisti di una vicenda dallo sviluppo lineare che segue una logica naturalistica e psicologica, poiché la psicologia non è una motivazione al loro agire, bensì una punizione; ma che arrivano, come caduti dal foro del cielo di carta, senz’alcun antefatto (17) a esprimere una condizione, astratta in quanto emblematica, all’interno di una parabola cerebrale e filosofica. Irrigiditi in maschere, per di più sconciati con furore; prosciugati nei tratti che, sempre essenziali, talvolta si piegano a un’evidente ed espressionistica deformazione.
(17) A. Leone De Castris, Storia di Pirandello, Bari, Laterza, 1978 [1962], pp. 147-48.
Ne risulta per il critico un’opera “sprovvista di calore, di sentimento, di umanità” che non “può sedurre, non può piacere alle donne. Può soltanto disorientare il pubblico” (18); un’opera in cui (è il caso in particolare del Giuoco) il procedimento è tanto rapido e sommario (fino a trascurare “gran parte di quelle giustificazioni che il pubblico, animale lento ad essere convinto, vuole ed esige” (19), “perché il pubblico, eterno ricercatore di sentimento e di passione, possa interessarsi con ardore alla vicenda” (20); perché, detto in altri termini, lo spettatore si possa emotivamente immedesimare e catarticamente consolare.
(18) S. d’Amico, “Così è (se vi pare)” all’Argentina, in “L’idea nazionale”, 16 novembre 1918.
(19) S. d’Amico,“Il giuoco delle parti” di Pirandello, al Quirino, in “L’idea nazionale”, 8 dicembre 1918.
(20) Ibidem
Da un lato, d’Amico inizia qui a proporre quanto articolerà con maggior agio in seguito, il carattere cioè non elitario del teatro e la necessità, per questo, che soddisfi almeno in parte le richieste più intime del pubblico (sentimenti e passione) evitando perciò di occuparsi di quanto ai più resta estraneo; dall’altro, porta avanti la propria poetica critica che, al contrario di quella pirandelliana, vorrebbe la psicologia a giustificazione della vicenda e dell’agire dei personaggi, come attestato di umanità, come luogo dell’autentico, come regola dei comportamenti. Perché l’umanità, anche se travagliata, inquieta, sbandata, episodicamente franta e priva di un’identità precisa, è sempre in ultima istanza per d’Amico l’espressione più intima e vera di un uomo che non ha perso il senso della totalità, dell’organicità di sé, del mondo in cui vive, del linguaggio che usa.
Quanto poi alle accuse di cerebralismo, si sa come fossero allora diffuse fra la critica: eppure d’Amico non si pone, né ora né successivamente, dalla parte di chi, facendo più o meno diretto riferimento alla poetica crociana e alla teoria della distinzione fra momento riflessivo e momento creativo, vedeva sia nella teoria dell’Umorismo sia nelle opere di Pirandello un’impropria associazione dei due elementi.
Piuttosto d’Amico, anche a questo proposito, sottolinea quanto la mania raziocinante di alcuni personaggi li raggeli, sottraendoli alla dimensione umana, e renda oscuro quanto sarebbe stato più semplice esprimere in poche e chiare parole. Ciò che a partire dalla prospettiva critica di d’Amico viene oscurato è proprio la funzione e il carattere di quella ragione in relazione alla poetica del personaggio umorista: una razionalità vuota e impotente, una delle “forme della scomposizione […] che il personaggio deve vivere”, “la più vana anzi la più ingannevole delle parti”, che prende il sopravvento solo come strumento di tortura, che si rivela presto quale vana illusione di compattezza e di dominio, come elemento culmine della disgregazione della persona e, insieme, tentativo più disperato della sua finzione unitaria, “la più tipica e illusoria e borghese delle molecole in cui egli soffre la sua dispersa unità” (21).
(21) A. Leone De Castris, Storia di Pirandello, cit., p. 143
Così accade per Baldovino, così per Leone Gala, per il Padre e così anche per Enrico IV.
Da questo punto di vista è emblematico che d’Amico trovi solo nel 1921 nelle parole del Padre dei Sei personaggi la chiave di lettura che ai suoi occhi fa tornare tutto, o quasi, e che rimarrà sostanzialmente invariata fino al necrologio: da questo momento in poi lo scrittore siciliano sarà per d’Amico “lo straziato poeta del soggettivismo e della relatività: ossia di questo nostro sciagurato tempo che ha perduto la fede in una realtà, in una verità oggettiva” (22).
(22) S. d’Amico, Pirandelliana, in “L’idea nazionale”, 11 ottobre 1921.
All’interno di tale prospettiva, si giustificano parzialmente quei personaggi che assumono l’aspetto di fantocci, quella “desolazione d’umorista atroce”, quel che di ingrato, di scheletrico e d’aspro è pre sente nelle sue opere (23) a cui prima di allora il critico non aveva trovato spiegazione.
(23) Ibidem.
La problematica oscillazione fra relativismo prospettico e relativismo assoluto, che caratterizza buona parte del percorso creativo di Pirandello, viene dunque risolta da d’Amico, ma si sa non solo da lui, tutta e solo nella seconda delle due opzioni. Il relativismo assoluto è fra l’altro più semplice da definire, più vicino alle posizioni del critico nella misura in cui rimuove il confronto serrato e complesso con la storia e, infine, più facilmente liquidabile una volta che ad esso venga opposto un assoluto di segno opposto (una fede) lasciando così libero il campo al riscatto e alla ricostruzione.
D’Amico sembra aver trovato la chiave: più che per aprire, per chiudere Pirandello entro un’interpretazione che possa porre la sua produzione artistica in una cornice chiara e definita (e definitiva), proprio in un momento in cui l’Italia si predispone a ricercare (culturalmente e politicamente) una via d’uscita dalla crisi (24).
(24) “Uno stesso equivoco insidiò la conclusione delle due guerre mondiali. Le filosofie irrazionalistiche, decadenti e mistiche, sboccarono in ritorni alla tradizione; e le pur nobili nostalgie che punteggiarono in entrambi i casi l’esperienza filosofica espressero una situazione chiusa che non riusciva a trovare una via nuova […]. La guerra, che era stata l’espressione crudele di una situazione di crisi, imponeva il problema di un ordine nuovo: di una sintesi che tenesse conto di tutti i termini in conflitto, li comprendesse e li risolvesse. Purtroppo in Italia si auspicò non di rado un assurdo ritorno a quelle posizioni medesime la cui inadeguatezza si era manifestata in modo così clamoroso, o si vagheggiarono infelici compromessi fra elementi inconciliabili”: E. Garin, Cronache di filosofia italiana. 1900-1960, Bari, Laterza, 1997 [1966], vol. II, p. 324. Si ricordi che sono gli anni in cui in campo letterario la “furia iconoclasta delle avanguardie ha ceduto il campo al classicismo illuminato (anche ironico e avventuroso) della ‘Ronda’ (1819-1923) e al calligrafismo della prosa d’arte”; in cui nei diversi campi artistici si inizia a proclamare la necessità di un ritorno all’ordine (dalla pittura metafisica di De Chirico, alla “bella pagina” tanto odiata da Palazzeschi; e, per fare due esempi specifici, un emblematico Tempo di edificare di Borghese e un’altrettanto significativa Storia di Cristo del neoconvertito Papini): vedi G. Tellini, Il romanzo italiano dell’Ottocento e Novecento, Milano, Mondadori, 2000, cap. XI: Il vento si è calmato).
Non si può dimenticare che pochi mesi prima, all’inizio di maggio, Eleonora Duse, tornata dopo anni di assenza alle scene, aveva fatto urlare al miracolo l’intera critica italiana – con pochissime eccezioni – (25), d’Amico compreso, che aveva presto individuato proprio nell’attrice il segno della rinascita.
(25) In occasione del ritorno della Duse d’Amico, per assistere alla prima della Donna del mare a Torino, rinunciò alla contemporanea prima dei Sei personaggi a Roma. Le sue cronache di quei primi spettacoli sono tutte caratterizzate da una medesima cifra che tende a collocare l’oggetto della riflessione fra la sfera estetica e quella dell’esperienza mistico-religiosa: S. d’Amico, Il ritorno trionfale della Duse al teatro. Una rappresentazione che assume il carattere di rito nazionale, in “L’idea nazionale”, 7 maggio 1921; Id., Eleonora Duse e “La donna del mare”. La seconda rappresentazione segna un nuovo trionfo dell’artista prodigiosa, in “L’idea nazionale”, 10 maggio 1921; Eleonora Duse, donna del mare, in “L’idea nazionale”, 14 novembre 1921. Il più esplicito e chiaro degli interventi, come si può evincere già dal titolo, è l’articolo scritto in seguito alla morte dell’artista dove il critico tenta una sintesi dell’intero percorso dell’attrice: S. d’Amico, Duse religiosa, in “Il Resto del Carlino”, 25 febbraio 1925. A questo proposito si veda il capitolo dedicato al ritorno della Duse in D. Orecchia, Il critico e l’attore. Silvio d’Amico e la scena italiana di inizio Novecento, Torino, Dams-Università degli Studi di Torino, 2003.
Allora, nei suoi numerosi interventi,il critico aveva dato a quelle recite un valore d’eccezionalità tale da superare i limiti consueti dell’arte teatrale: quasi un rito dai connotati religiosi di cui la Duse sarebbe stata l’officiante e la folla la comunità lì riunita nella condivisione di valori comuni. Insomma, pur nell’eccezionalità dell’evento, d’Amico aveva potuto allora trovare per la sua esigenza di rinascita e certezze, un punto d’appoggio concreto.
Pirandello in questo contesto di ricostruzione inizia ad essere l’emblema di un presente che scolora già nel passato: la crisi (quella filosofica e sociale ma elitaria) sta veramente per terminare dal punto di vista del critico. Non così la crisi del teatro, quella di un istema sulla via del tramonto definitivo, che è altra cosa e della quale d’Amico si occuperà a lungo e con caparbia determinazione proprio in questi e nei successivi anni.
Non stupisce dunque che il “dramma dell’espressione mancata” (26) dei Sei personaggi (la crisi dell’arte) interessi poco d’Amico: in quel dramma Pirandello mette in questione la struttura stessa dell’opera e, con essa, la funzione organatrice e sintetizzatrice dell’autore –colui che avrebbe dovuto ma non ha potuto dare un senso (un valore universale) e una ragione a personaggi che avevano già una vita (27).
(26) S. d’Amico, Pirandelliana, cit.
(27) Così nella premessa del 1925. E allora, si potrebbe obiettare che da questo punto di vista l’edizione del 1921 è più confusa.
Ma, per non parlare degli antecedenti delle novelle, si ricordi che d’Amico ripete il medesimo giudizio quasi con le stesse parole, nell’articolo pubblicato su “Commedia” dal titolo Ideologia di Pirandello (20 novembre 1927), così come nelle pagine dedicate al drammaturgo del suo Il teatro italiano, Milano-Roma, Treves-Treccani-Tumminelli,1932.
E invece d’Amico in un inciso del suo intervento dimostra che o non ha capito o non vuole capire e attribuisce a Pirandello una nuova difesa della forza e centralità del poeta: il dramma dell’espressione diviene nella penna di d’Amico il dramma “dei sei personaggi che, balenati alla mente dell’autore ma rifiutati da lui si recano da un capocomico, perché voglia l’attore dar loro quella forma d’arte che il poeta ricusò ad essi (e che il poeta solo può conferire)”: come se il poeta avesse alternative; come se lo scacco non fosse innanzitutto suo e dell’arte; come se si trattasse solo di un dramma mancato e non impossibile.
La prospettiva critica di d’Amico non contempla che il linguaggio stesso e la sua logica siano in crisi, che il senso dell’arte lo sia, che il potere di dire la verità lo sia. Non contempla che l’arte possa farsi denuncia proprio di questo stato di impotenza e di impossibilità e non tanto, come invece sosteneva Croce giusta la sua teoria dei distinti, perché le venga negato lo statuto di arte. Piuttosto perché la componente critico distruttiva e tragica propria dell’arte di Pirandello, che riassume in sé la componente riflessiva per denunciare le mistificazioni della ragione tradizionale responsabile dello stato di alienazione e di scissione dell’uomo contemporaneo, non può essere consolatoria. E dal punto di vista di d’Amico questo è il limite più grande: perché non è la difesa di un’arte disinteressata a muovere la sua critica a Pirandello, bensì la sua ansia di composizione organica della società e dell’individuo, la ricerca di una soluzione, l’intolleranza per la denuncia dell’impasse e del paradosso, per una ragione amaramente scettica e rabbiosamente impotente a offrire soluzioni.
2.
Il 1925 è per molti aspetti un anno cardine della vita politica e culturale italiana, che prelude a un periodo fra i più cupi della nostra storia nazionale: il 3 gennaio Mussolini pronuncia davanti alle Camere il discorso con cui dà l’avvio ufficiale alla dittatura; seguono le prime leggi fasciste, fra cui quella sulla libertà di stampa, l’intensificazione dell’intervento e dei controlli del regime sulla vita culturale con la fondazione, fra l’altro, di alcuni importanti istituti di cultura (28).
(28) Nel febbraio viene costituito l’Istituto Giovanni Treccani che si occuperà di pubblicare l’Enciclopedia italiana diretta da Giovanni Gentile, di cui, si ricordi, le voci di materia teatrale verranno in un primo tempo affidate proprio a d’Amico; nel giugno dello stesso anno viene fondato l’Istituto nazionale fascista di cultura; nel 1926 l’Accademia d’Italia.
Il 1925 è inoltre l’anno del Manifesto degli intellettuali fascisti (redatto da Giovanni Gentile) a cui risponde Il manifesto degli intellettuali antifascisti (redatto da Benedetto Croce). Fra il ‘25 e il ’26 vengono arrestati Terracini e Gramsci, vanno in esilio Salvemini e Gobetti; nel ’27 morirà Amendola in seguito a un’aggressione fascista.
Il clima politico si fa difficile per chi mantiene un atteggiamento apertamente conflittuale, mentre un processo di normalizzazione e di razionalizzazione del sistema si espande gradualmente investendo tutti i settori della cultura (innanzitutto l’istruzione e il giornalismo, ma ben presto il cinema, la musica, il teatro, la radio…), conquistando via via sempre maggiori aree di consenso aperto o di silenzi complici.
Non si può e non si deve dimenticare questo complesso e contraddittorio contesto quando si tratta del teatro di questi anni, come se, nel caso specifico, il percorso di Pirandello e quello di Silvio d’Amico potessero essere indagati prescindendo da quel particolare clima culturale, artistico e teatrale.
Il 1925 è, si sa, l’anno d’apertura del Teatro d’Arte dove comincia per il drammaturgo l’attività di uomo di teatro a tutti gli effetti; l’inizio delle direzioni sceniche, del contatto diretto con gli attori e del mutamento di prospettiva nei loro confronti (29), del rapporto con la materialità del teatro (dalla scenografia, alle luci, alle musiche, gli aspetti economico-organizzativi e, non da ultimo, al pubblico). E poi è l’anno dell’incontro con Marta Abba.
(29) Non è certo la sola Abba a far mutare giudizio a Pirandello sull’attore. Come testimonierà in un articolo del 1935 è proprio il frequentare direttamente il palcoscenico che lo costrinse a guardare il problema da un nuovo punto di vista; a vedere cioè che ci sono dei momenti più o meno frequenti nella recita in cui gli attori possono essere tanto immedesimati nel personaggio che pur recitando le parole del testo è “come se lo creassero essi spontaneamente e si ha la precisa impressione che potrebbero seguitare, almeno per un certo tempo, a parlare spontaneamente senza ‘tradire’ la parte”: L. Pirandello, La diminuzione dei nostri grandi attori dipende dalla supremazia del regista?, in “Il dramma”, 1 luglio 1935.
Per d’Amico invece sono gli anni dell’impegno per il rinnovamento della scena italiana, degli incarichi ufficiali e, di lì a poco, dei viaggi in Europa alla ricerca di altre e diverse esperienze teatrali (30); dell’incontro con la regia (con Copeau, con Reinhardt, con Pitoëff), con il teatro e gli attori di altre nazionalità (russa, norvegese, inglese, ceca oltre che francese e tedesca).
(30) In questo d’Amico ebbe certamente una funzione molto importante e sprovincializzante: contro la politica nazionalista e protezionistica del regime fascista, il critico a partire dalla metà degli anni venti sarà spessissimo all’estero rarefacendo pertanto i suoi interventi di cronaca locale, ma moltiplicando i resoconti e le testimonianze dei suoi viaggi e dei suoi incontri con le realtà teatrali più significative di quegli anni in Europa. Da questo punto di vista un’interessante raccolta di pezzi critici si ritrova sulle pagine della “Gazzetta del popolo” di Torino negli anni che vanno dal 1927 al 1935; pezzi quasi esclusivamente dedicati al teatro estero, a differenza delle cronache sulla “Tribuna” dove d’Amico continua, sebbene con minore frequenza rispetto al passato, a commentare per lo più quanto accade in Italia intrecciando agli articoli di cronaca riflessioni più generali e riservando uno spazio episodico agli interventi dall’estero.
Intanto in Italia complessivamente i tempi sembrano chiedere con urgenza una soluzione al disfacimento del sistema teatrale prostrato ormai da tempo, da un lato, dalle logiche di monopolio e dall’altro –ma non è certo questione disgiunta dalla prima– dalla competizione errata del cinematografo e di altre forme di intrattenimento. Negli ambienti teatrali si parla di crisi ciclicamente in questo periodo, di una crisi che si rivela strutturale e che porterà nel corso degli anni venti e trenta a un mutamento profondo della scena teatrale italiana. Analisi, interpretazioni, proposte di soluzione si moltiplicano sulle testate dei quotidiani e dei periodici, progetti di rinnovamento e di intervento statale si accumulano sulle scrivanie dei ministri che, per il momento, tenderanno a rimandare la questione ad altri tempi: ciascuno movendo dal proprio modo di intendere il linguaggio della scena, il rapporto con la tradizione, con i processi produttivi e le forze economiche, avanza la propria idea.
Così mentre Pirandello nel 1926, insieme a Paolo Giordani, proporrà a Mussolini la creazione di un Teatro Drammatico Nazionale, Silvio d’Amico nel 1931 presenterà il suo progetto per una riforma del teatro al Ministero delle Corporazioni, su richiesta dello stesso Bottai (progetto che vedrà la sua parziale realizzazione prima con la costituzione dell’Istituto nazionale del teatro drammatico e poi, soprattutto, con la creazione dell’Accademia d’Arte drammatica nel 1935) (31).
(31) Per tutte le questioni relative alle diverse proposte di riforma teatrale proposte in quegli anni si vedano E. Scarpellini, Organizzazione teatrale e politica del teatro nell’Italia fascista, Firenze, La nuova Italia editrice, 1989 e G. Pedullà, Il teatro italiano nel tempo del fascismo, Bologna, Il mulino, 1994.
Ma questi non sono che gli atti ufficiali, perché poi gran parte dell’attività di d’Amico, volta a estendere sempre più la propria visione delle questioni che riguardano la vita teatrale italiana, si articola e si dipana attraverso un’ininterrotta produzione scritta di interventi –in volume o su quotidiani e su periodici–, dove la tensione militante, di cui si diceva da principio, trova ora un alimento in parte differente. Progressivamente si viene infatti smorzando l’elemento conflittuale che aveva caratterizzato gli anni precedenti, ora sostituito da una sempre più accentuata volontà propositiva e riformatrice. Ed ecco come nel 1924 il critico aveva impostato il problema in una lettera personale a Cavacchioli:
Caro Cavacchioli,
per me il problema è nel sottrarre la direzione delle Compagnie agli attori.
I grandi virtuosi, se ne nascono ancora, recitino per conto loro: noi andremo a sentirli per ammirar loro, non gli autori ch’essi deformeranno. Ma gli attori secondari (e intendo tutti quelli oggi viventi in Italia, salvo qualche vecchio, e qualche dialettale) bisogna farli diventare quel che devono, strumento del poeta.
Dove trovare chi sappia dominare e foggiare cotesto strumento? ecco il circolo vizioso. Regisseurs ce n’è in Russia, in Francia, in Germania, in America: in Italia manca perfino la parola. Bisogna inventarli. Se si comincia male, come è accaduto varie volte, si compromette la bontà della causa. Ma se non si comincia mai, si rinuncia a combatter per la causa.
Quanto al programma mi par logico che ogni direttore abbia il suo: se no perché fa il Direttore? Io sono pel grande teatro eclettico, con annesse scuole di recitazione e di scenografia, nel quale si reciti da Shakespeare e da Moliére a Shaw e a Pirandello: e ciò perché, come disse altri, prima di far l’eccezione in Italia si deve ancora crear la Regola. Ma se per ragioni di proporzioni, o economiche, o altro, s’ha da cominciare con un teatro piccolo, cominciamo da uno piccolo.
Sia eclettico, sia legato a una determinata scuola poetica (ce n’è?) […]. Attori? trovare i più malleabili, i più disposti a essere dominati; questa qualità per me deve prevalere anche sulla loro cultura; gente che possa diventar veramente strumento nelle mani del capo; però che siano attori (32).
(32) S. d’Amico, Lettera a Enrico Cavacchioli, 6 novembre 1924, conservata presso il Civico Museo Biblioteca dell’Attore di Genova, Fondo Silvio d’Amico, cartella “Corrispondenza”.
Ecco dunque per d’Amico i nodi principali della situazione teatrale italiana alla vigilia della fondazione del Teatro d’Arte: sottrarre ai grandi virtuosi la direzione delle compagnie, affidarla a direttori (futuri registi), educare gli attori alla malleabilità, creare una nuova Regola che si ponga alla base del nuovo sistema teatrale nazionale e, come specificherà di lì a poco, trovare un maestro, l’uomo nuovo che sappia indicare la strada del rinnovamento nazionale (33).
(33) Moltissimi sono in questi anni gli interventi di d’Amico sul rinnovamento del teatro italiano, visto soprattutto come riforma dell’organizzazione del sistema teatrale, delle compagnie, degli attori e della loro direzione; e proprio in questo periodo il critico inizia a richiedere con sempre maggiore insistenza un uomo nuovo, un maestro, che coordini tale rinnovamento. Su questo argomento si veda almeno un suo articolo dal titolo emblematico, Si attende un maestro, in “La tribuna”, 15 ottobre 1926, che seguì a un altro, anch’esso emblematico, La decadenza dei nostri attori. Una lettera di Vincenzo Morello, in “La tribuna”, 1 ottobre 1926.
Nell’ottobre 1924 d’Amico, sebbene nella lettera a Cavacchioli avesse sostenuto che in assenza di una Regola sarebbe stato necessario cominciare da un piccolo teatro e sebbene in un primo tempo avesse accettato di firmare l’atto costitutivo del “Teatro dei Dodici” diretto da Pirandello, futuro Teatro d’Arte (34), alla formalizzazione dell’atto fa marcia indietro e non firma.
(34) Sul “Convegno” di Milano il 30 agosto 1924 era comparso un articolo in cui si rendeva noto l’atto costitutivo di un teatro detto “Teatro dei Dodici”, con la firma, fra gli altri, anche di d’Amico.
Ritorna in parte sulle sue posizioni di diffidenza nei confronti dei ‘piccoli teatri’ (35) e preferisce restare spettatore e critico di quell’iniziativa.
(35) D’Amico era intervenuto poco tempo prima con un articolo polemico contro il fenomeno dei “piccoli teatri” italiani, espressione più di un velleitarismo dilettantesco, che non di una vera forza di rinnovamento della scena. Altrove –in Francia per esempio con il Théatre Libre di Antoine– in paesi in cui “l’eccezione ha avuto ragione d’esistere perché c’era la regola, è chiaro che ciò è potuto avvenire o in quanto essi servivano a lanciare opere di così nuovi caratteri estetici che il pubblico dei grandi teatri non le avrebbe accettate, o in quanto servivano a introdurre nuovi metodi di recitazione”: S. d’Amico, I piccoli teatri, in “L’idea nazionale”, 9 gennaio 1925. Si veda a questo proposito anche uno dei molti articoli polemici nei confronti di Anton Giulio Bragaglia, Teatro di Stato e Teatro Sperimentale. Marinetti e D’Errico agli ‘Indipendenti’, in “La tribuna”, 1 febbraio 1927.
Entrato direttamente nella vita pratica della scena, Pirandello ha ormai finito di rappresentare per d’Amico un vero e proprio alleato nella sua lotta contro la decadenza del teatro e in particolare degli attori italiani: il percorso del drammaturgo, ora capocomico e regista, non può proporsi come regola. È piuttosto l’eccezione che, se richiede di essere seguita con attenzione, mai potrà diventare una proposta alternativa alla regola morta, mai potrà essere l’esempio per una riforma complessiva e centralizzata del sistema teatrale.
Eppure il Teatro d’Arte di Pirandello, a differenza di molte altre iniziative di quegli anni, nasce per d’Amico sotto i migliori auspici: teatro d’élite, sì, ma con l’approvazione del governo, sostenuto da buona parte dell’intellettualità teatrale italiana, collegato alla Scuola di Santa Cecilia e diretto da uno dei drammaturghi più conosciuti e affermati in Italia. Un “teatro sui generis” lontano dai “soliti dilettanti volonterosi e incerti” e dai “loro inadeguati repertori” (36); un teatro che l’eccezione non rende autoreferenziale e chiuso all’interno di una cerchia di affezionati, ma che, forse, potrebbe essere d’esempio e di stimolo.
(36) S. d’Amico, Il ‘Teatro dell’Arte’ di Pirandello, in “L’idea nazionale”, 4 aprile 1925.
Per tre anni d’Amico, come la gran parte dei critici italiani, segue da vicino il lavoro di Pirandello, ne recensisce la programmazione, ne loda spesso la direzione e, necessariamente, si confronta con la giovane prim’attrice della compagnia, Marta Abba. Proprio negli articoli di cronaca a questo triennio e nei giudizi rivolti all’attrice e al suo ‘maestro’ –e ora anche capocomico– è possibile trovare le tracce di una nuova tappa del percorso dei due uomini di teatro e del loro rapporto.
Se per Pirandello, dunque, la Abba (37) è colei che lo porrà di fronte all’esempio di un attore-artista in senso pieno che, fra l’altro, sconta sulle assi del palcoscenico un travaglio simile a quello che lo scrittore da anni sta denunciando (l’impossibile unità e organicità dell’opera d’arte; per d’Amico sarà un’attrice brava e interessante, a patto di restare sotto la tutela del suo drammaturgo-direttore, entro cioè una cornice ben definita.
(37) Sul rapporto Pirandello Marta Abba si ricordi il carteggio fra i due, testimoniato in L. Pirandello, Lettere a Marta Abba, a cura di B. Ortolani, Milano, Mondadori, 1995 e in M. Abba, Caro maestro… : lettere a Luigi Pirandello (1926-1936), a cura di P. Frassica, Milano, Mursia, 1994. Inoltre su “Il dramma”, n. 362-363, nov-dic 1966 (numero dedicato a Pirandello a trent’anni dalla morte), sono raccolti fra gli altri la Prefazione a “I giganti della montagna” e un altro intervento di Marta Abba, due saggi di G. Calendoli sul rapporto di Pirandello con Martoglio e Marta Abba e uno di E. D’Errico sulla Abba. Per ciò che riguarda gli studi contemporanei: A. Barbina, Taccuino pirandelliano: Marta Abba, in “Ariel: Quadrimestrale di drammaturgia dell’Istituto di Studi Pirandelliani e sul Teatro Italiano Contemporaneo”, Numero monografico dedicato a Pirandello nel 50° anniversario della morte, settembre-dicembre 1986; l’intero numero monografico di “Il castello di Elsinore”, n. 33, 1998, i cui materiali derivano dal Convegno, promosso dal DAMS di Torino, dal titolo La scrittura e l’assenza. Lettere di Pirandello a Marta Abba – Torino, 6-7 maggio 1997; R. Alonge, Appunti su Pirandello, Marta Abba e il cinema, in AA. VV., La passione teatrale: tradizioni, prospettive e spreco nel teatro italiano: otto e novecento. Studi per Alessandro d’Amico, Roma, Bulzoni, 1997 e R. Alonge, Madri, baldracche, amanti. La figura femminile nel teatro di Pirandello, Milano, Costa & Nolan, 1997.
Brava e interessante ma incapace di misura: l’insofferenza per l’ostentazione della finzione, dell’artificio e la prepotenza proprie dello stile di Marta Abba, che in seguito alla separazione dal ‘maestro’ verranno duramente attaccate dal critico, sono per il momento sottolineate solo con perplessità. D’Amico, ne apprezza la duttilità ma solo se ordinata all’interno di un quadro, dentro qualcosa che possa definirsi ancora misura umana; ne apprezza l’istinto, ma solo se educato da qualcuno: in sintesi, anche a proposito della Abba, d’Amico sembra dire sì, ma con moderazione. E la Abba, come Pirandello, non sceglie la moderazione.
Proprio nell’eccesso, nella recitazione ostentata e gelida, nel tratto quasi virile, nel parossismo recitativo, nel rifiuto prepotente e quasi sprezzante tanto a fondersi con il personaggio quanto a concedersi allo spettatore (38), l’attrice svela il gioco della maschera della naturalezza indossata da altri. Insieme mette in scena il proprio “dramma dell’espressione” che, come nel caso delle altre arti, è anche per l’attore il dramma dell’impossibile organicità e compiutezza della sua opera, dello straziato sgretolarsi delle certezze e di un punto di vista unitario.
(38) Nella recita della Donna del mare, per esempio, sfida quanto mai ardua data la memoria ancora viva dell’evento-Duse, Marta Abba manifesta “qualcosa di acerbo, di duro, di non completamente terso che rende la sua recitazione qualche volta disuguale e spesso la allontana un po’ troppo dal pubblico”, una “specie di prepotenza […] che è sì personalissima, ma che è anche una ribellione a fondersi completamente col personaggio e ad avvicinarsi a chi l’ascolta”: [E. Bertuetti], “La donna del mare” di Ibsen al Teatro Carignano, in “Gazzetta del popolo”, 20 febbraio 1927.
Tanto in personaggi già caratterizzati dal tratto antinaturalistico (da Dea alla signora Perrella, alla Figliastra) quanto in quelli da questo punto di vista più ambigui (Ellida della Donna del mare, per esempio), Marta Abba sottolinea la finzione e, avvicinandosi talvolta pericolosamente alla dimensione tragica, per eccesso la strania crudelmente, in ciò incontrando perfettamente il maestro (39) ma deludendo, inevitabilmente, il critico.
(39) “La crudeltà di Pirandello è nel vietare ai personaggi la tragedia, via della tragedia, contro il fato o contro gli uomini, e in questo rifiuto è uno dei segni della sua modernità”: G. Macchia, Pirandello o la stanza della tortura, Milano, Mondadori, 2000, p. 81.
Nella cronaca a Diana e la Tuda (40), per esempio, quel “furore di nudità” con cui pare che l’autore “abbia strappato di dosso alle sue creature non solo le vesti ma la pelle, le abbia scorticate e addirittura scarnificate”, ha qualcosa di eccessivo tanto che sembra che i personaggi stessi “si compiacciono di questa ostentazione”, mentre un’atmosfera “incandescente”, che è tuttavia “d’un fuoco di astri lontanissimi, che a noi non danno calore”, è un ostacolo per lo spettatore ingenuo “desideroso di comunione e d’abbandono” (41).
(40-41) Silvio d’Amico, “Diana e la Tuda” di Pirandello all’Argentina, in “La tribuna”, 12 marzo 1927.
La tensione esasperata, che eccede la misura umana, tanto di Pirandello-regista quanto di Marta Abba determinano uno straniamento da ogni dimensione anche solo lontanamente naturalistica e denunciano l’impossibilità dei personaggi così come dell’opera d’arte –e dell’attrice che la recita– non solo di frequentare la tragedia, ma anche di consistere pienamente in una forma compiuta e organicamente definita.
E d’Amico, come non fu mai interessato al “dramma dell’espressione” della drammaturgia di Pirandello (neppure nella sua forma più chiara e quasi didascalica dei Sei personaggi), non può certo mostrarsi ora interessato a quello dell’attrice: la quale, fra l’altro, per quanto brava, attrice resta e pertanto non potrà mai raggiungere l’altezza dell’arte e della Poesia. Dunque, a rigor di logica, non ha nessun “dramma dell’espressione” da esprimere.
Gli elogi agli allestimenti, alla compattezza stilistica del complesso degli attori, al repertorio per lo più contemporaneo e italiano, si accompagnano per tutti i tre anni di attività del Teatro d’Arte a un basso continuo di perplessità più o meno manifeste, che vanno dall’esasperazione dei toni nelle recite, all’assenza di umanità dei personaggi e di poesia nelle rappresentazioni; perplessità tutte complessivamente collocate entro il contesto polemico poco fa ricordato.
A ciò si aggiunga che, a partire dal 1927, d’Amico intensifica i suoi viaggi all’estero, volti a conoscere direttamente alcune delle esperienze teatrali più significative di quegli anni, a rafforzare la propria posizione di critico in territorio nazionale e dare spessore e credibilità alle proposte di rinnovamento della scena che proprio allora va elaborando. Anche da questo punto di vista Pirandello, il suo teatro e la sua drammaturgia perdono quel posto centrale e privilegiato che per anni avevano mantenuto anche nella prospettiva critica di d’Amico.
3.
Nel 1928, all’indomani della chiusura del Teatro d’Arte, nel numero di ottobre-novembre della rivista “Comoedia”, Silvio d’Amico pubblica un articolo dal titolo In margine alla crisi. Domande e risposte (42).
(42) In risposta a un questionario diffuso da “Paris et le Monde” sulla situazione teatro europeo contemporaneo.
Qui, dopo avere individuato la peculiarità del dramma di inizio Novecento nel suo antagonismo rispetto al “realismo, figlio del positivismo” che aveva dominato l’arte europea sulla fine dell’Ottocento e nel relativismo, nel soggettivismo, nel solipsismo dettati dallo “smarrimento spirituale” di quegli anni di crisi in cui “ogni fede è sembrata sciogliersi”, d’Amico riconosce in Pirandello uno dei più significativi rappresentanti di quella temperie culturale d’inizio secolo. Dunque anch’egli promotore della filosofia propria di quel tempo di crisi che avrebbe negato qualunque cosa trascenda l’individuo, qualunque verità, certezza, fiducia nel futuro; anch’egli, come e più di altri, non solo espressione dello smarrimento ma responsabile di non aver assolto al compito dell’arte del teatro: “arte sociale, che si rivolge alle grandi masse” per dare certezze e consolazione.
E così termina, significativamente, l’articolo: “Il gran successo di domani sarà pel poeta che ripronuncerà una parola di fede”.
L’esigenza di trovare una soluzione alla ‘crisi’ del teatro (ma in fondo per d’Amico, alla crisi tutta) spinge il critico a dichiarare ormai conclusa la storia precedente. Al negativo si viene ora a contrapporre come ineluttabile, senza soluzione di continuità e secondo una giustapposizione volontaristica, il positivo di una nuova nascita e di una rinnovata conciliazione: la certezza che quel futuro semplice veicola senza titubanze (il successo sarà, la fede ritornerà) pone il lettore immediatamente in una dimensione futura che ha superato con un doppio salto mortale il presente e le sue contraddizioni.
Si vengono così a delineare nella riflessione di d’Amico di questi anni più modalità, più contesti e dunque anche più accezioni deltermine crisi.
Innanzitutto c’è la crisi di cui parlano Pirandello e i grotteschi che, sostiene il critico in un’intervista concessa in risposta a un articolo in cui Giovanni Papini aveva accusato gli italiani di non essere “atti a fare romanzo né teatro”, ha un vizio comune a fenomeni simili in altri paesi europei: essere espressione sincera, ma spesso ingrata, di un tormento spirituale assai profondo, ma effettivamente sentito, in tutti i paesi, soltanto da una piccola élite di intellettuali. Il Dramma contemporaneo ha avuto il torto di estraniarsi dall’anima delle folle; da quella comunione con esse onde il teatro ha sempre vissuto (43).
(43) Il teatro italiano esiste! Una risposta di Silvio d’Amico a Giovanni Papini, in “Gran Bazar”, 28 febbraio 1929, p. 6.
Come a dire: questa crisi è in realtà ormai (o forse lo è sempre stata e ovunque) il problema di un’élite e come tale, non può che interessare quell’élite, tanto in Italia quanto all’estero. Il teatro al contrario è un’arte che più delle altre deve rivolgersi a un ampio pubblico, una folla, da cui essere compresa. Dunque delle due l’una: o si fa teatro o si esprime la crisi.
C’è inoltre la crisi interna al sistema teatrale, che altro non è se on il definitivo tramonto del sistema ottocentesco contro il quale il critico combatte ormai da anni.
C’è infine una crisi più ampia, che coinvolge tutta la collettività e che, specificherà d’Amico nel 1931 (44), è crisi religiosa, di condivisione e di “legame sociale”.
(44) S. d’Amico, La crisi del teatro, in “Pegaso. Rassegna di lettere e arti”, gennaio 1931, poi confluito in La crisi del teatro, Roma, edizioni di “Critica fascista”, 1931.
Di questo tipo di crisi il critico parla solo nel momento in cui i tempi sembrano dargli la chiave per una soluzione, non ancora presente, ma impellente e certa. Non a caso siamo negli anni trenta: certo infatti è allora il ritorno della fede e dei valori; certo è che il loro stesso esistere ricomporrà l’ecclesia, la comunità; certo infine è che in un nuovo clima etico, sociale e politico si richiederà una nuova forma d’arte:
Sicché quando il clima etico, sociale e politico, mutò nel modo che tutti sanno; quando si tornò a guardare ai valori della Vita come degnissima di essere vissuta, dono di Dio; quando fu trasmessa la nuova parola d’ordine ‘tempo d’edificare’; la gente trovò che il cosidetto nuovo teatro [i grotte schi] non era più così nuovo, era anzi in ritardo. E non solo, badiamo, come contenuto, ma come forma (45).
(45) S. d’Amico, Tendenze nuove del dramma italiano, in “Scenario”, aprile, 1932, p. 34.
Noi crediamo alla verità del fatto, della carne […]. Noi crediamo nella Legge […]. Noi aneliamo a ricomporre la sintesi armoniosa fra Regola sociale, e aspirazione individuale: noi aspiriamo all’Ordine (46).
(46) Op. cit., p. 35.
A tempi nuovi, arte e Ordine nuovi. Fra le righe, ma non troppo: a tempi nuovi e pubblico nuovo, arte nuova. Perché sempre più si fa chiaro agli occhi di d’Amico che crisi religiosa e crisi di pubblico corrono parallele e che per risolvere l’una è necessario interrogarsi con serietà sulla seconda, tanto più che l’esperienza di altri diversi pubblici stranieri ha favorito nel critico una visione più ampia e complessa della questione, tale da poter supportare e irrobustire la sua ipotesi di rinascita religiosa del teatro (47).
(47) Due esempi per tutti. Innanzitutto l’articolo dal titolo Il pubblico di Goethe del settembre del 1931 da Monaco di Baviera dove d’Amico sta assistendo alla rappresentazione di Stella, dramma di Goethe. Dopo un rapido commento allo spettacolo, il critico aggiunge: “E c’incantò la devozione del pubblico, il quale ascoltava i cinque atti col raccoglimento di una folla di fedeli in un tempio”; e poi nel medesimo articolo, a proposito delle recite dell’Ifigenia in Tauride: “Ma l’altro spettacolo, ripetiamolo, era in platea: dove un pubblico, immoto per i cinque atti del rito, alla fine si trattenne lunghissimamente ad acclamare i suoi artisti, con applausi di una convinzione, d’una insistenza e diremmo d’una tenerezza tali, da edificare il più scettico contemplatore […]. È crediamo nel bisogno organico che questa razza prova di adunarsi, di sentirsi una, gomito a gomito”. S. d’Amico, Il pubblico di Goethe, in “Gazzetta del popolo”, 15 settembre 1931. Si ricordino poi i numerosi interventi su Dàncenko, verso il quale la simpatia e la stima di d’Amico fu sempre spiccatissima, non solo perché drammaturgo, ma perché regista, maestro d’attori, riformatore: “L’essenza della riforma concepita, e presto attuata, da Dàncenko e dal suo grande collaboratore [Stanislavskij ovviamente], fu anzitutto nel ritornare alle origini del miracolo scenico: ossia nel sostituire, al mestierante, il credente, e all’istrione, l’asceta”: De Gustibus, L’Osteria della posta. Saluti a Dàncenko, in “La tribuna”, 3 gennaio 1932. Si noti l’insistenza sui termini che pertengono al campo semantico della ritualità religiosa (rito, tempio, fedeli, credente, asceti) e che accostano, come è consueto in questi anni per d’Amico, il teatro all’evento rituale, l’attore all’officiante, il pubblico alla comunità dei fedeli.
Ed è proprio su questo aspetto che ancora una volta gli interessi di d’Amico e di Pirandello si incontrano e le prospettive critiche si differenziano. La questione relativa al pubblico, alla sua conformazione, cioè, alle variazioni che va subendo in quegli anni, alla sua massificazione, al rapporto che con esso stabilisce il regime nelle forme di spettacolarizzazione del proprio potere e alle parallele strategie implicite ed esplicite che chi si occupa a vario titolo della scena teatrale deve attuare nei suoi confronti, è ormai posta in primo piano da entrambi. E interrogarsi sul pubblico nel corso degli anni trenta significa affrontare il problema della concorrenza del cinema ma anche, non dimentichiamo, degli spettacoli sportivi, dell’industrializzazione della scena, del ruolo svolto dalla propaganda fascista, dell’appello di Mussolini per un teatro per ‘ventimila spettatori’, e così via.
Significa, fra l’altro, ricordare che, se nel corso di tutti gli anni venti il governo fascista aveva mantenuto un atteggiamento sostanzialmente cauto nei confronti della vita e dell’organizzazione dello spettacolo, il nuovo decennio e la raggiunta stabilità del regime alla giuda del paese segnano una maggiore intenzione interventista (48).
(48) Da un lato –qui come in ogni settore– la diffusione dell’ideologia corporativa (la costituzione della “Corporazione dello Spettacolo” è del 1930) mira a rimuovere la tensione conflittuale fra le categorie in nome di una superiore conciliazione, che è poi salvaguardia degli interessi economici delle componenti più forti (proprietari dei teatri e delle compagnie); dall’altro, il controllo della produzione (la nuova legge per la censura dei testi è del 1931) e la politica delle sovvenzioni (cui si aggiungono i premi e gli anticipi), la creazione dell’ “Ispettorato generale del teatro” nel 1935 (diventato l’anno successivo “Direzione generale del teatro”), contribuiscono al processo di normalizzazione della scena in funzione di una razionalizzazione del suo sviluppo, ovviamente poco artistico e molto industriale.
All’interno di tale contesto le riflessioni d’Amico e Pirandello nel corso degli anni trenta occupano un posto di rilievo non solo per le personalità che le esprimono, ma anche perché si fanno emblematiche di due punti di vista su un comune problema, espressione ancora una volta di percorsi di ricerca che provengono da culture profondamente diverse e che indicano linee di sviluppo parimenti lontane l’uno dall’altra.
Da un lato, il punto di vista di d’Amico che da anni ormai, e ora sempre più, intende porre in primo piano un’idea di pubblico ampio, indifferenziato e astratto –una folla–, in ciò incontrandosi con il clima di quegli anni, con la tendenza diffusa cioè all’identificazione del singolo in una collettività compatta o nel capo carismatico (49); dall’altro Pirandello, che ribadisce in particolare con la sua ultima opera incompiuta, I giganti della montagna, una posizione scettica e pessimistica sul futuro del teatro.
(49) “Essa dà agli individui un illusorio senso di prossimità e unione: ma proprio questa illusione presuppone l’atomizzazione, alienazione e impotenza dei singoli. La debolezza dei singoli nella moderna società […] predispone ciascuno anche alla debolezza soggettiva, alla capitolazione nella massa dei seguaci. L’identificazione, sia col collettivo, sia con la figura strapotente del capo, offre all’individuo un surrogato psicologico per quel che gli manca nella realtà”: M. Horkheimer e Th. Adorno, Lezioni di sociologia, Torino, Einaudi, 1966, p. 96.
Da un lato c’è d’Amico che esprime in questi anni con forza e determinazione la necessità di creare un teatro in cui la folla possa sperimentare ancora quella condivisione di valori che il contatto vivo con la ‘ritualità’ spettacolare può permettere; un teatro che, come fu alle sue origini e come la Duse aveva testimoniato poteva ancora essere nel presente, possa essere nuovamente il luogo della condivisione del sacro, di “una fede comune” e di “una certezza” intorno alla quale il popolo si possa “riadunare religiosamente” (50).
(50) S. d’Amico, Tramonto del grande attore, Milano, Mondadori, 1929, p. 255. E inoltre: “Che luce, che calore, che consolazione, se domani tornasse una fede comune, e riadunasse religiosamente il popolo, in una certezza! Soltanto allora […] l’attore sarebbe sanato dalla sua stessa finzione, e tornerebbe a essere il sacerdote che fu da principio”: Op. cit., p. 255. Si veda anche S. d’Amico, Duse religiosa, in “Il Resto del Carlino”, 25 febbraio 1925 dal quale l’ultimo capitolo (L’attore e la grazia) del Tramonto è tratto.
In sintesi, un teatro in cui si celebri il superamento della crisi, in qualunque delle tre accezioni sopra riportate il termine venga usato: crisi d’élite (ormai fuori tempo), crisi del sistema teatrale (ora finalmente affrontata anche dall’intervento ufficiale del governo), crisi religiosa (che la retorica diffusa del rinnovamento culturale e dei valori nuovi permette di indicare come superata già nel presente).
Dall’altro c’è Pirandello che, anche in conseguenza della sua esperienza pratica e da questo punto di vista fallimentare di direttore del Teatro d’Arte, si sofferma piuttosto sulla fragilità del teatro, sull’incomprensione di un pubblico sempre più ostile e sordo alle proposte della scena contemporanea e, a modo suo, sposta ma non elimina la questione della crisi.
Anche di questo parlano I giganti della montagna, ultima e incompiuta opera drammatica di Pirandello (51).
(51) La commedia, come disse Pirandello in un’intervista del 1928, “risulta una satira del pubblico e della critica nei riguardi del teatro pirandelliano e anche, a considerarla più vastamente, una satira del nostro tempo per quello che ha di eccessivo nel culto della forza fisica che rischia di brutalizzare la vita ove non sia contemperata dal culto dei valori spirituali”: L. B. [L. Bottazzi], Visita a Pirandello, in “Corriere della sera”, 13 ottobre 1928.
Qui Ilse, orgogliosamente teatrante “nel sangue, di nascita” (52), l’attrice/artista dall’ “eroico martirio” (53), vaga con la sua compagnia decimata dalle fatiche, dai rifiuti del pubblico, dalla morsa in cui il mercato stringe la loro attività artistica (54), mentre Cotrone e gli scalognati “artisti falliti, rifiuti della società”, “esiliatasi dal mondo per crearsi una vita fuori dalle comuni regole” (55), “agli orli della vita” (56) compiono quotidianamente nella loro villa straordinarie magie per tenere lontana la gente: Ilse, fragilissima, dalla voce stupenda che può solo più recitare a frammenti sempre la medesima parte, e Cotrone, “un omone barbuto, dalla bella faccia aperta, con occhioni ridenti splendenti sereni, la bocca fresca, splendente anch’essa di denti sani tra il biondo caldo dei baffi e della barba non curati” (57) sono le due alternative speculari a cui lo spettacolo teatrale sembra essere destinato.
(52) L. Pirandello, I giganti della montagna, in Id, Quando si è qualcuno, La favola del figlio cambiato, I giganti della montagna, a cura di R. Alonge, Milano, Mondadori, 1993, p. 180.
(53) Op. cit., p. 181.
(54) “Ilse- […] Se non fossi nata attrice, capisci? Il mio schifo è questo, che dobbiate esser voi, proprio voi i primi a crederlo e farlo credere agli altri… ‘Vuoi una buona scrittura? – Vènditi’ ”: Ibidem.
(55) Si tratta di parole di Pirandello in P. Solari, Tre nuove opere di Pirandello, in “La gazzetta del popolo”, 1° giugno 1930.
(56) L. Pirandello, I giganti della montagna, cit., p. 199.
(57) Op. cit., p. 172.
E se la Contessa e la sua compagnia, che invano vagano alla ricerca di un pubblico, sono l’emblema di un teatro che non trova all’altezza della metà degli anni trenta un suo spazio (o meglio detto, un suo pubblico), le magie di Cotrone, che al contrario sembrano aver risolto persino il problema impostato nei Sei personaggi, dando cioè immediata forma fantastica ai sogni interiori, non risolvono tuttavia ancora una volta né il problema del senso compiuto e organico del teatro –perché quei sogni ancora una volta sono “come ci riesce di farli, incoerenti” perché “[c]i vogliono i poeti per dar coerenza ai sogni” (58) –; né quello complesso della materialità del teatro che tanto aveva travagliato il giovane Pirandello; né quello del rapporto del teatro, e dell’arte tutta, con il mondo, ovvero dell’impossibile autonomia totale dell’arte dalla società.
(58) Op. cit., p. 226.
E le questioni non vanno separate: le apparizioni fantastiche di Cotrone, immagini vive (59), che germinano spontanee per necessità dalla fantasia, sono utili a spaventare e tenere lontana la gente dalla villa e si fanno protagoniste di fantastici giochi, di una ritualità tutta realizzata nell’isolamento di una piccola comunità; ma sono immagini smaterializzate, prive di corpi, lontane in questo dalla concretezza del teatro, possibili solo in quello spazio separato dal mondo e, dunque, inutili alla finalità di Ilse di portare la Favola “in mezzo agli uomini” (60).
(59) “– Cotrone […] A noi basta immaginare, e subito le immagini si fanno vive da sé. Basta che una cosa sia in noi ben viva, e si rappresenta da sé per virtù spontanea della sua stessa vita. È il libero avvento d’ogni nascita necessaria”: op. cit., p. 230.
(60) Op. cit., p. 212.
Ed Ilse, teatrante “nel sangue”, che vive nella e della concretezza del teatro, vuole invece portare quella recita per il mondo, al cospetto dei Giganti, di fronte a quel pubblico, cioè, che probabilmente non capirà e la rifiuterà ancora una volta.
L’ultimo dei ‘Miti’ pirandelliani, lungi dal fornire una soluzione catartica, una fuga mistica e consolatoria, esprime ancora una volta il paradosso del teatro in un preciso e concreto tempo storico: in forma diversa e focalizzandosi ora su un aspetto differente rispetto al passato, Pirandello denuncia qui l’aporia di quell’arte nel suo rapporto con il mondo industrializzato e massificato, costretta alla concorrenza con il cinema sonoro, fragile e impotente; denuncia il paradosso di un gesto artistico che sconta la sua vanità e inefficacia, non ontologica e assoluta, bensì concretamente storica.
4.
In occasione della morte di Luigi Pirandello, l’11 dicembre 1936, Silvio d’Amico scrive sulla “Tribuna” un lungo necrologio dal titolo L’ora di Pirandello. In quella estrema sintesi finale, il critico riconferma la sua lettura del percorso artistico del drammaturgo senza aggiungere particolari nuovi dettagli: Pirandello resta un “documento significativo nella storia dello spirito europeo: antiverista, antipositivista, antiborghese”, testimonianza importante di un’epoca che fu segnata profondamente dalla crisi “di un credo e d’un mondo”, alla quale, come d’Amico già da tempo aveva iniziato a sostenere,“un altro credo succederà e dopo la quale prima o poi un altro mondo si ordinerà” (61).
(61) S. d’Amico, L’ora di Pirandello, in “La tribuna”, 11 dicembre 1936.
L’ora di Pirandello è ormai finita, in tutti i sensi.
Oppure, è, dai tempi di Sofocle, sempre la stessa ora. Come sosterrà l’anno successivo, ma come già in parte aveva sostenuto nel corso di quei vent’anni, per chi non si ponga nella prospettiva della fiducia cattolica nella redenzione, la tragedia dell’uomo –“la tragedia del problema della conoscenza” (62) – di cui parla Pirandello è la medesima di Edipo. Sottratta al contesto storico di riferimento, la crisi assume così connotati ontologici, identificandosi con la tragedia eterna dell’uomo.
(62) S. d’Amico, Edipo e Pirandello, in “Scuola e cultura”, febbraio 1937, p. 14.
Di qui la grandezza della tragedia sofoclèa; prodigio che non solo anticipa di millenni certe conquiste, d’ordine, diciamo così, meccanico, del comune teatro, ma allo stesso tempo canta, in vicende e parole d’un’attualità eterna, la disperazione dell’uomo trastullo degli Dèi. Ossia di quel Destino atroce che, diceva Pirandello, lo condanna all’illusione, o, se gli consente di uscirne, alla catastrofe (63).
(63) Op. cit., p. 16.
Ecco che con un ossimoro, l’attualità eterna, d’Amico rimuove dal discorso sull’arte il rapporto fra l’opera e il contesto storico concreto, riconfermando in tal modo l’idealismo di base della sua prospettiva critica.
Nulla di nuovo avrebbero pertanto espresso scrittori e drammaturghi all’inizio del Novecento, e nulla di nuovo avrebbe scritto Pirandello.
E, così, privata del proprio contesto reale di lotta e di scontro, disciolta in un eterno e astratto senza tempo, anche la forza dei più ‘corrosivi’ testi pirandelliani si scioglie nell’eterna disperazione, che solo il salto nella fede può risolvere in conciliazione e speranza.
Donatella Orecchia
Dalla rivista “L’Asino di B.” 2006 – Undicesimo numero
da L’Asino Vola – link diretto documento originale in PDF: vedi biografia
Silvio D’AmicoDall’Enciclopedia dello Spettacolo, vol. 4, coll. 42-45 Scrittore e critico drammatico. Italiano, direttore dell’Enciclopedia dello Spettacolo, nacque a Roma il 3 febbraio 1887 [morto ivi il 1° aprile 1955]. A Roma frequentò le facoltà universitarie di giurisprudenza, lettere e filosofia, laureandosi in giurisprudenza. Dal 1911 fu assunto per concorso del Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale antichità e belle arti. Dal 1915 al 1917 fu volontario nella prima guerra mondiale. Nel 1923 lasciò il Ministero, essendo stato nominato prof. di storia del teatro nella R. Scuola di Recitazione presso l’Accademia Di S. Cecilia in Roma. Nel 1935, invitato dal governo a formulare il progetto per un’accademia d’arte drammatica in Roma, ne fu nominato presidente, conservandovi la cattedra di storia del teatro. Intanto fin dall’ottobre 1914 era entrato nella redazione del quotidiano romano L’Idea nazionale come vice del suo critico drammatico Domenico Oliva. Morto l’Oliva nel 1917, e terminata la guerra, gli succedette alla fine del ’18 come titolare della rubrica, tenendo anche la direzione della terza pagina del giornale. La stessa rubrica tenne dal 1925 nella Tribuna, con cui L’Idea nazionale si era fusa, e dal 1941 al ’43 nel Giornale d’Italia, che abbandonò all’epoca dell’occupazione tedesca. Dal 1945 riprese la critica drammatica nel Tempo di Roma. Oltre che sui quotidiani predetti, esercitò continuativamente la stessa critica in più periodici: dal 1923 al ’28 su La Festa di Milano, dal 1934 al ’46 su La nuova antologia, dal ’52 su L’approdo e su L’Illustrazione italiana. Dal 1945 fu pure titolare delle cronache drammatiche alla Radio Roma. Ha fondato, e dal 1932 al ’36 ha diretto insieme con Nicola De Pirro, la rivista teatrale Scenario, dal 1937 al ’43 ha diretto la Rivista italiana del dramma (poi Rivista italiana del teatro), pure da lui fondata, e edita dalla Società degli autori; ha diretto la collana critica “Il Teatro del Novecento” edita da Treves (5 voll. di differenti autori: Italia, Francia, Inghilterra, Germania, Russia), e la collana di testi teatrali intitolata “Repertorio” per le edizioni Roma (21 voll.). Ha collaborato a importanti quotidiani e periodici italiani e stranieri, nonché all’Enciclopedia italiana (dove ha diretto la Sezione del teatro) e all’Encyclopaedia Britannica. Ha tenuto conferenze e corsi di lezioni sul teatro italiano in molte città d’Italia e in Francia, Spagna, Svizzera, Austria, Belgio, Polonia, Cecoslovacchia, Romania, Grecia, Malta, Argentina, Uruguay, Brasile. È stato delegato dell’Italia in più congressi internazionali del teatro (Parigi, Barcellona, Zurigo, Roma) e della critica (Praga), segretario del Convegno Volta per il teatro presieduto in Roma da Luigi Pirandello presso l’Accademia d’Italia nel 1934; presidente del Congresso dell’Institute International du Théâtre a Venezia nel 1952. Tralasciando d’esporre qui altre sue attività svolte in libri di viaggi e di letteratura a sfondo cattolico, si ricorda che, per quanto riguarda la critica della letteratura drammatica, le sue ricerche d’un teatro nuovo, fuori dell’ormai stanca “routine” ottocentesca, cominciarono a concretarsi nei primi, incerti saggi raccolti in un volume intitolato Il Teatro dei fantocci (1920), dove tentava un esame (da lui stesso poi rettificato e in parte rifiutato) degli autori italiani e di alcuni illustri stranieri venuti in voga nel primo dopoguerra. Due anni dopo, egli proponeva nell’Idea nazionale (11 ottobre 1921) la prima interpretazione italiana di Pirandello come poeta tragico dell’ora europea; a cui nello stesso giornale (dicembre 1921 e aprile 1922) seguì la polemica con Marco Praga, sul tramonto del teatro naturalistico. Poi nel volume Il Teatro italiano (1932, primo della citata collana “Il Teatro del Novecento”) intese illustrare la riacquistata originalità del dramma italiano, finalmente uscito dalla imitazione ottocentesca del francese. Più tardi, nei 4 volumi della sua Storia del teatro drammatico (universale, 1939-40), dove si traccia per sommi capi l’evoluzione del dramma e della sua rappresentazione, ha rilevato il posto d’onore occupato dal teatro italiano nella civiltà umana. Sparsi saggi sul valore specialmente morale del più vario teatro moderno ha raccolto nel volume Dramma sacro e profano (1942). Nel 1944 ha iniziato il piano della Enciclopedia dello Spettacolo. Quanto alla pratica del teatro, all’interpretazione scenica, all’organizzazione, ai rapporti con lo Stato, ecc., fin dagl’inizi della sua attività D’Amico dichiarava la propria delusione per la frattura prodottasi tra la vita della scena e quella dello spirito italiano; e invocava, oltre alla protezione dello Stato al teatro d’arte (ma non mai la sua burocratizzazione), la guida del direttore illuminato in luogo della prepotenza del cosiddetto divo o mattatore (Maschere, 1921). Tali invocazioni divennero più consapevoli dopo i primi viaggi di D’Amico all’estero (Tramonto del grande attore, 1929) e propugnate sempre più chiaramente dalla citata rivista Scenario, nel cui primo fascicolo (1932), tra l’altro, si proponevano per la prima volta le parole regia e regista. Alla discussione di problemi pratici oltre che estetici erano dedicati altri suoi volumi: La Crisi del teatro (1931), Invito al teatro (1935), Il Teatro non deve morire (1945); alla dimostrazione dei compiti del regista, il volume da lui curato, La Regìa teatrale (1947), e il suo sommario storico della regia attraverso i secoli, Mettere in scena (1954). Infine, accettando il mandato di dar vita a una moderna scuola nazionale di arte scenica, e di presiederla, egli intese costituire un centro che fosse di preparazione insieme tecnica e culturale, per fornire alla scena italiana i suoi moderni interpreti, non solo attori, ma anche (novità guardata con maggiori diffidenze) registi. A contrastare quelle diffidenze, D’Amico, dal novembre 1939 all’aprile 1940, si pose a capo di un gruppo di suoi giovani allievi, che nell’ambiente teatrale fu battezzato “Compagnia dell’Accademia”; e che, svolgendo un particolare repertorio classico (Jacopone, Shakespeare, Gozzi, Metastasio) e moderno (Barrie, Betti, Angeli, Evreinov), rivelò al pubblico delle più assortite città italiane alcuni dei registi e attori oggi più noti. A essi hanno poi seguito molti altri, usciti dalla stessa Accademia, o ispirati ai suoi principi e al suo esempio. Il giorno della sua morte tutti i teatri di Roma rimasero chiusi in segno di lutto, mentre in quelli di Milano, Torino e Bologna lo scomparso fu commemorato in un intervallo: ai funerali, celebrati a spese della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Comune di Roma, dell’Accademia d’arte drammatica e del quotidiano Il Tempo, si alternarono ai cordoni i maggiori esponenti del rinnovato teatro italiano. Al suo nome s’intitolarono sia l’Accademia d’arte drammatica che la Scuola del Piccolo Teatro di Trieste; inoltre un premio annuale istituito dalI’IDI per uno o più saggi critici riguardanti la letteratura dramm. ital. dall’inizio del secolo a oggi. |
Se vuoi contribuire, invia il tuo materiale, specificando se e come vuoi essere citato a
collabora@pirandelloweb.com


